Salvemini, l’intellettuale che al fascismo contrappose il monito a “non mollare”
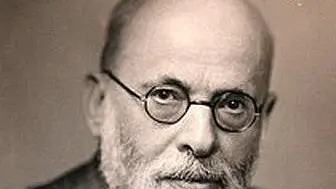
UDINE
Domani, lunedí, alle 17.30 a Udine, in sala Gusmani, a palazzo Antonini, per il ciclo “Ritratti e testimonianze dell’Italia civile”, a cura dell’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione e dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (con il patrocinio dell’Università degli studi di Udine e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia), lo storico Valerio Marchi ripercorrerà alcuni frangenti della vita di Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957). Proponiamo qui un’introduzione all’incontro.
Quando nel 1963 pubblicò il suo “Gaetano Salvemini”, Massimo Luigi Salvadori premise che la cultura italiana del Novecento era stata sin lì dominata da Croce, Gentile, Gramsci e Salvemini. Tuttavia, mentre i primi tre furono i massimi esponenti della cultura e della visione del mondo di strati e classi sociali ben determinati, Salvemini rimase sempre, su diverse trincee, un franco tiratore.
Salvadori offrì una mirabile ricostruzione della lunga, talora contraddittoria esistenza dell’illustre storico e uomo politico pugliese (peraltro assai stimato all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove visse e lavorò per lunghi anni): dal socialismo militante alle grandi battaglie antigiolittiane (basti ricordare il suo celebre saggio – del 1910, riedito nel 1919 – “Il ministro della mala vita”) e democratiche (suffragio universale, riforma della scuola, soluzione della questione meridionale), dall’interventismo democratico nella Grande Guerra alla lotta antifascista, al secondo dopoguerra, al radical-socialismo…
Di Salvemini, assieme agli inevitabili, umani limiti, emergono nitidamente tanto il formidabile impegno politico e civile, quanto il fascino del suo stile morale di vita: lo studio e l’insegnamento della storia e l’impegno politico erano infatti per lui ambiti inscindibili.
Di lui hanno scritto in Italia altri nomi di prestigio fra i quali, per esempio, Enzo Tagliacozzo, Gaspare De Caro, Norberto Bobbio, Giovanni Grasso o Gaetano Quagliarello, il cui “Gaetano Salvemini”, del 2007, ha affrontato tematiche poco studiate e proposto letture nuove di altre già esplorate.
Di recente, un altro tassello l’ha aggiunto Filomena Fantarella, che insegna lingua e cultura italiana alla Brown University di Providence (Rhode Island): il suo libro “Un figlio per nemico. Gli affetti di Gaetano Salvemini alla prova dei fascismi” (Donzelli editore, con prefazione di Salvadori) colma una lacuna, analizzando intense e in alcuni casi tragiche vicissitudini personali di Salvemini.
Se nel 1908 il catastrofico sisma di Messina sterminò la sua prima famiglia, nel 1946 la condanna a morte del figliastro Jean, divenuto nella Francia occupata dai tedeschi il “Führer della stampa collaborazionista” (così venne definito), determinò il crollo della seconda.
Di mezzo, altri “terremoti” infierirono contro Salvemini: eppure, nonostante gli strazi interiori che lo facevano pensare costantemente al suicidio, egli rimase sempre fedele al motto che fu anche il nome del foglio antifascista cui contribuì nel 1925: “Non mollare”.
Una storia densissima, che pare un film. E che potrebbe anche diventarlo. —
V.M.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








