Un paese ribelle istigato dal parroco: “Cosean del no”
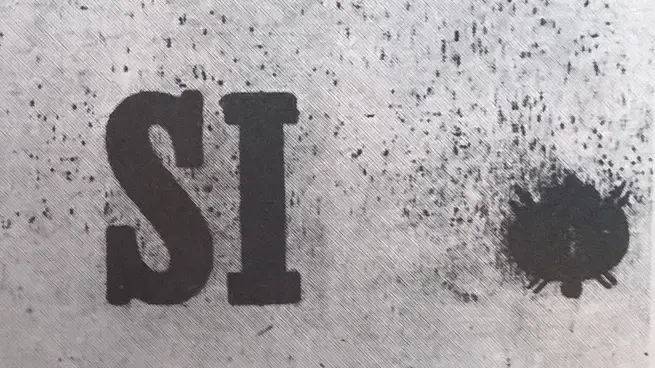
UDINE. «Si cantava nella Metropolitana di Udine il solenne rendimento di grazie a Dio, per la pace seguita il 3 del mese tra l’Austria e l’Italia. Tutte le campane della città suonavano in quella mattina a gran festa, e tutta la città era ornata da migliaia e migliaia di bandiere ricolorate. La popolazione di Udine era in grande movimento, e tutta composta a solenne festa nazionale…».
Cosí scrisse l’illustre carnico Giambattista Lupieri, testimone di quei fatti del 10 ottobre 1866, nell’imminenza del plebiscito. Fra la “massima esultanza” - registrò ancora - l'Arcivescovo Andrea Casasola e il Commissario del Re Quintino Sella assistettero assieme anche alla preghiere per il Re.
Pochi giorni prima, il Sella aveva osservato che la pace di Vienna del 3 ottobre era stata accolta dai più «come si fosse trattato di una pace tra la Cina e il Giappone».
Ma ciò non deve sorprendere, e non solo per la “riservatezza” dei friulani, che Sella comunque stimò sempre, reputandoli gente “ottima”. La situazione era stata infatti a lungo disorientante e ricca di incognite, fra cui un possibile ritorno austriaco. In primo luogo, però, pesava lo scontro interno fra clericali e anticlericali, destinato peraltro a protrarsi nell’Italia unita e attestato dall’atteggiamento fra il contrario e l’attendista dell’Arcivescovo.
Non solo, ma nel clero v’erano posizioni di segno diverso, dal piú convinto austriacantismo sino all’aperta adesione a prospettive patriottiche e filoliberali. Tuttavia, quando si consolidò la situazione militare e diplomatica il Casasola, pur senza entusiasmo, ruppe gli indugi e prese atto che - così disse - la Provvidenza aveva ormai stabilito il «dominio dell’Augusta Maestà di Vittorio Emanuele II»: allora, salvo eccezioni, i parroci si allinearono più o meno convintamente sul “sì” e tanti friulani si sentirono sgravati dal dubbio di coscienza.
Quintino Sella appuntò che il contegno inizialmente tenuto dall’Arcivescovo rendeva molti “perplessi, afflitti”, e che a causa di ciò il plebiscito rischiava di essere “svogliato”, specialmente fra i contadini (più influenzati dal clero), guastando la “grande festa nazionale”. Già il 10 ottobre, però, il Commissario regio constatò che Udine sapeva uscire dalla sua “freddezza abituale”. Il 21, poi, scrisse che il plebiscito si svolgeva ordinatamente «frammezzo al più grande entusiasmo» e che il popolo accorreva dalla campagna «numerosissimo, festante e con molta parte di clero».

Il quesito chiedeva di dichiarare l’unione al Regno d'Italia sotto il Governo monarchico-costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Nella provincia di Udine (comprensiva dell’odierno Pordenonese), a fronte di quasi 145 mila “sí” i “no” accertati furono 36, di cui 25 espressi nel distretto di San Daniele dai votanti di Coseano (perciò noto come “Cosean dal no”).
Il Giornale di Udine parlò di un «mostruoso scandalo» causato da alcuni «reazionari ignoranti» e dai «sentimenti retrivi» del parroco don Luigi Riva, “reo” di avere precisato dal pulpito ai parrocchiani che erano liberi di votare “no”,spingendoli «indirettamente al voto negativo». La sua fu interpretata dunque come una chiara indicazione di voto (“no”) ai coseanesi, forse confusi persino sul senso del “sí” e del “no”. C’è anche chi sostiene che, in quel caso, non si ebbero come altrove brogli e forti pressioni per il “sí”. Ma come stabilirlo, ora?
Pochi giorni dopo, a San Daniele, don Riva subí l’ira dei piú facinorosi. Riparatosi per alcune ore in una locanda, fu liberato dall’intervento della Benemerita, travestito da carabiniere. Ma venne riconosciuto e, mentre si dirigeva verso la natia Majano, ricevette ancora fischi, insulti, minacce. In novembre, poi, a Coseano fu sottoscritto un indirizzo al Re per «protestare contro i 25 sedotti dal parroco, i quali non sapendo quello che facevano deposero il “no” nell’urna». (va.mar.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto









