Ragagnin, il poeta-negoziante che dava del tu ai grandissimi
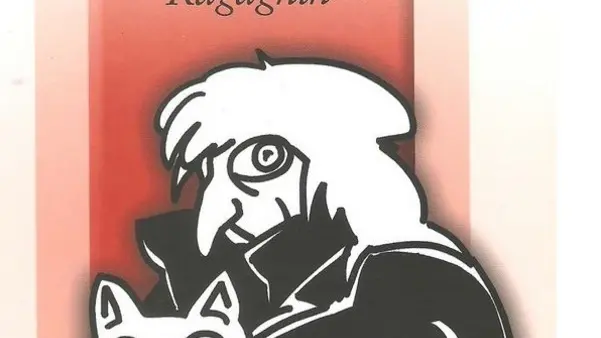
di PAOLO MEDEOSSI
Il 7 maggio 1976 il professor Edoardo Sanguineti prese carta e penna e da Genova inviò questa lettera a un amico di Buja: «Caro Ragagnin, ti prego, appena possibile, di darci buone notizie di te e dei tuoi. Siamo molto ansiosi e preoccupati». E Ragagnin rispose: «Stiamo tutti bene, per tutti intendo me e la famiglia di mia moglie perché, per il resto, parenti e amici, si sono rotolati fin sulla porta... Io, che sono vissuto sempre in quest’unico posto, non sopporto di vederlo qui sbriciolato come fosse stato solo una quinta. Mia madre è morta da 10 anni, ma adesso se n’è andata per davvero. Mi sento freddo. Gli usignoli cantano di giorno, anche i grilli. Se si sta fermi si sente il boato da una direzione sempre disconosciuta finora: da giú, sotto i piedi, ma da una distanza che ci scredita qui sulla crosta». Questo breve scambio epistolare, che avvenne con i tempi e le modalità della posta non esistendo allora sms, facebook o skype, può essere l’inizio, il dato di partenza per narrare una storia singolare e praticamente sconosciuta, a conferma che il mondo della letteratura friulana contiene una miniera inesauribile di volti, vicende e opere. Restano nascoste a lungo, sotto cumuli di disattenzione e indifferenza, finchè il lavoro appassionato di personaggi sempre fondamentali dovunque (potremmo chiamarli “i tessitori di sogni”, citando cosí un libro di Patti Smith) le riportano alla luce in qualche modo, come nel caso di Giovanni Ragagnin, protagonista a sorpresa nel piccolo mondo di un nostro microcosmo.
Citando all’inizio il 7 maggio 1976 è chiaro a quale momento tragico ci si riferisca. Siamo all’indomani del terremoto che devastò ampia parte del Friuli, Buja compresa, essendo a due passi dall’epicentro. Lí viveva e lavorava Giovanni Ragagnin, nato nel 1926, che gestiva in paese il negozio di calzature continuando cosí l’attività dopo la morte del padre. Ma perché Sanguineti, docente all’università di Genova, nome celebre nell’avanguardia che voleva rinnovare dalle fondamenta la letteratura italiana negli anni Sessanta tramite il gruppo 63, gli scrive quell’allarmato biglietto? E perché Ragagnin risponde un po’ incerto, anche confuso, volendo comunicare di non aver riportato danni diretti dal sisma, che però aveva sconvolto il mondo attorno (e lo fa con pochi, poetici, commossi accenni)? Va allora spiegato che i due strinsero amicizia durante i convegni di scrittori e poeti nei quali avevano avuto modo di scambiarsi giudizi e pareri, pure sulle rispettive opere. Occasioni schiette e ad ampio raggio, nelle quali si affrontavano i temi piú diversi, discorrendo di libri, politica e ideologie, come si usa fra chi è in confidenza e sulla stessa lunghezza d’onda, umana e culturale. Dai messaggi postali ricordati all’inizio abbiamo, al di là delle testimonianze fornite da chi ha conosciuto Ragagnin, la prova piú efficace e intensa di questo rapporto sincero che legava il famoso professore a un commerciante di scarpe di Buja, uno mai mossosi in pratica dal paese, a parte i viaggi su una vecchia Topolino, di cui pochi al d. i là della cerchia di parenti e intimi conoscono l’esistenza, che merita dunque di essere raccontata pubblicamente. Questo avverrà, dopo un convegno già organizzato nel 2013 (a dieci anni dalla morte), oggi, mercoledí 11 febbraio, alle 17.30, nell’atrio di palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Joppi a Udine, dove sarà inaugurata (con il patrocinio dell’università) “La forma e la scrittura”, una mostra bibliografica a cura di Carlo Londero. Seguirà alle 18 nella sala Corgnali un incontro sul tema “Un libro per Giovanni Ragagnin” per presentare un’iniziativa con cui pubblicare gli atti del convegno al quale, oltre a Londero, intervennero Rodolfo Zucco, Rudi Fasiolo, Marina Marcolini, Laura Nascimben e in particolare il pittore Renato Calligaro, che ebbe un grande rapporto di amicizia con il sorprendente poeta bujese, animando assieme a lui iniziative di impatto, di cui si è persa memoria, ma che è doveroso rievocare per spiegare come idee e passione, anche in luoghi piccoli e remoti, possano produrre fenomeni stupendi.
Diciottenne, Giovanni Ragagnin partecipò alla Resistenza nel battaglione Libertà della Brigata Osoppo e nell’estate del 1944, spinto dal fervore delle giovani generazioni di allora, fondò con alcuni coetanei l’Accademia bujense degli Accesi, la cui attività, durata fino agli anni Cinquanta, esortava la gente della zona collinare ad agire per una vera ricostruzione sociale attraverso dibattiti, incontri, mostre d’arte e la rivista “Richiamo”. A sostegno di ciò, Ragagnin si mise a scrivere articoli per quotidiani e settimanali, concependo pure un romanzo sulla lotta di Liberazione. Tanti sogni, come accade a ogni ragazzo, dovettero fare i conti con la realtà di ogni giorno. L'Accademia si spense e Ragagnin cominciò, pur gestendo il negozio di famiglia, una sua ricerca personale avvicinandosi alle avanguardie letterarie degli anni Sessanta, senza complessi d’inferiorità dovuta alla marginalità friulana rispetto ai centri della cultura italiana. Cosí mutò stile di scrittura, incontrò personaggi del livello di Sanguineti incuriosendoli e pubblicando il primo libro, “Rattle!”, sulla guerra partigiana nel Carso. Stampato da una cooperativa, la prefazione è di Luigi Malerba, il quale parla di «spinta provocatoria che colma un abisso individuale, uno spavento di fronte agli accadimenti e alla loro corruzione temporale». Poi nel 1994 l’editore Manni di Lecce pubblica “A Pla Tà” che, sempre con stile originale, molto onirico, narra (come spiega lo stesso Ragagnin) «la scena di un terremoto da dopo il tramonto». Anche in questo caso autorevole la firma del prefatore, Romano Luperini. Nel 1998 esce “Vibrido” mentre è postumo, del 2006, “Il tipo”, edito ancora da Manni, un vagabondaggio notturno con l’unica compagnia di un gattino-coscienza. A presentare l’opera è un’introduzione di Elio Bartolini mentre la copertina è un ritratto dell’autore visto da Altan.
Questa, dunque, la sintesi della storia ed è comprensibile se un gruppo di giovani di studiosi si è cosí tanto appassionato. Assieme a loro, come detto, c’è Renato Calligaro, fondamentale per capire il contesto in cui Giovanni Ragagnin agí: negoziante bujese di giorno, ma con la mente altrove, a indagare «la preminenza della forma-contenitore sul significato-contenuto», cercando un proprio stile di scrittura ed espressione, di rottura con gli schemi tradizionali friulani. Una scelta totale di libertà, durata tutta una vita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








