Premio Friuli Storia, tra i finalisti Carlo Fumian con Pane quotidiano
Il saggio indaga la nascita del mercato mondiale del grano tra XIX e XX secolo: dalle prime multinazionali agli effetti delle guerre. Il vincitore
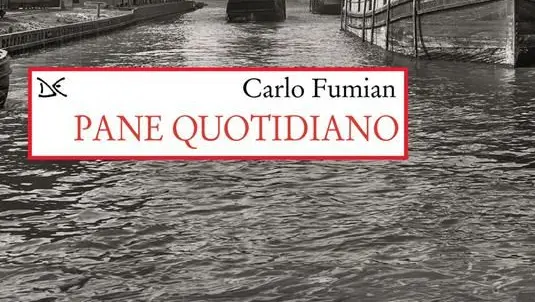
Continuiamo la presentazione dei tre finalisti del Premio Friuli Storia con il saggio di Carlo Fumian “Pane quotidiano. La creazione dell’invisibile mercato mondiale del grano tra XIX e XX secolo” (Donzelli, 2024).
Il vincitore sarà determinato dalla giuria dei lettori entro il 31 agosto 2025. La cerimonia di premiazione si terrà a Udine in autunno.
Esponendo un tema che esplora «un gigantesco “turning point” dell’intera storia umana», Flumian – professore emerito di Storia contemporanea all’Università di Padova, autore di altre pubblicazioni attinenti a questo tema ed esperto di storia del terrorismo italiano ed europeo – ha inquadrato i decenni da metà Ottocento sino alla Prima guerra mondiale iniziando da un lato dall’attualità (la guerra in Ucraina) e dall’altro, con una necessaria incursione nella storia moderna, dai «complessi e angusti mercati di ancien régime».
«Nel 2022 – ci racconta –, al tempo dell’invasione russa in Ucraina e dunque del coinvolgimento di due dei maggiori esportatori di grano, ero nel pieno della scrittura del mio lavoro. A quel punto mi attendevo grandi ripercussioni (sui traffici, sui prezzi…); invece, a dimostrazione che il mercato mondiale era in grado di reggere una crisi così severa, vi furono solo alcune fibrillazioni, in particolare sul mercato dei futures».
A partire da questa considerazione, il libro individua il momento storico, i luoghi cruciali (il caso più significativo è quello del Chicago Board of Trade, sorto nel 1848, che offriva futures per i cereali già alla metà degli anni sessanta dell’Ottocento) e i meccanismi di un mutamento molto rapido, delineando il processo storico grazie al quale, tra Otto e Novecento, è sorto un mercato globalizzato capace di assorbire anche i colpi più duri. E certo le carestie, un tempo inesorabilmente ricorrenti, non sono finite, ma oggi si tratta perlopiù di «carestie politiche, nel senso che non c’è l’impossibilità tecnica di trasferire il cibo da un punto all’altro, bensì dipendono da una volontà politica».
Se poi ci domandiamo a che cosa si riferisca l’aggettivo “invisibile” contenuto nel sottotitolo, Fumian spiega che «invisibili sono soprattutto coloro che hanno agito in vario modo nella costruzione del mercato mondiale del grano: infatti dalla metà dell’Ottocento, in Europa e negli Stati Uniti, si affermarono alcune grandi dinastie di mercanti di grano, rimaste programmaticamente nell’ombra, riservatissime protagoniste di una Rivoluzione commerciale nella quale il grano divenne una merce “facile” da trasportare e negoziare su scala planetaria. Le prime grandi multinazionali nacquero in quell’epoca, a ridosso del mercato del grano».
Fra i punti di svolta, centrale è stato quello della guerra civile americana, che «obbligò lo stesso governo americano del Nord a impegnarsi direttamente nell’acquisto e nella vendita di futures per comprare il grano e l’avena, indispensabili per nutrire quantità immense di uomini e animali: fu la fine del primato del cotone, mentre la “corona” passò al grano e gli Stati Uniti divennero protagonisti del mercato mondiale».
Naturalmente, una spinta decisiva venne anche da tecnologie e sviluppi quali il telegrafo (una specie di “internet” dell’epoca, che consentì finalmente la rapida circolazione delle informazioni), gli elevator, i grandi studi sulla moderna oceanografia, i progressi della navigazione, il Canale di Suez…
Parallelamente, molti paesi europei producevano sempre meno grano, importandolo dagli americani e, soprattutto, dai russi.
Ebbene, pure in questo caso «si aprì una gara invisibile, misteriosa anche storiograficamente, con gli Stati Uniti che raggiunsero e poi superarono il più grande esportatore di grano, ovvero l’Impero zarista, refrattario alla modernizzazione della propria agricoltura: quella modernizzazione che forse – la storia, e vero, non si fa con i “se”, ma la storiografia qualche volta sì – avrebbe fatto reagire meglio alla catastrofe della Grande guerra, evitato la Rivoluzione, fatto vivere meglio i contadini russi (e ucraini) nel XX secolo». —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








