Luc Dardenne: “Senza Dio l’uomo resta solo davanti alla paura di morire”
Il regista belga, premio Udine Filosofia 2025 per “L’affare umano”, riflette sul senso del limite, sull’arte come atto di compassione e sul suo nuovo film “Giovani madri”, in proiezione al Visionario
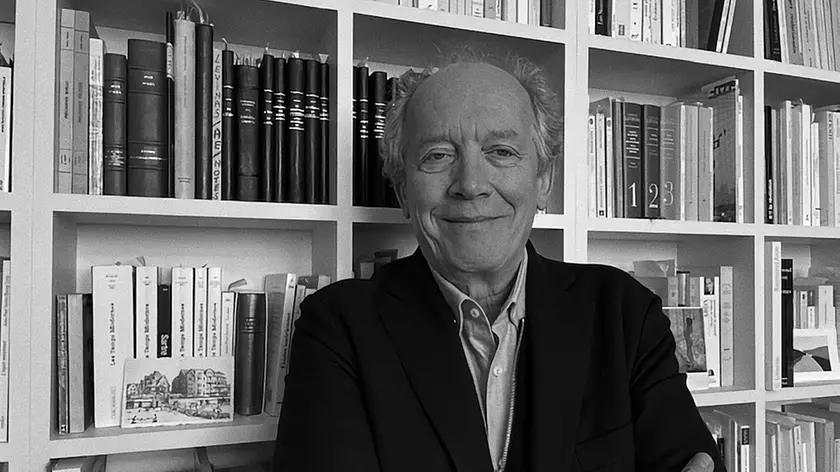
Il regista francese Luc Dardenne riceverà il Premio Udine Filosofia 2025 – Libro dell’anno oggi, sabato 25 alle 19, al Visionario di Udine. La cerimonia sarà introdotta da Francesco Pitassio, docente di Storia del Cinema, condurrà Damiano Cantone. Seguirà la proiezione del film Giovani madri, girato con il fratello Jean Pierre Dardenne, premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2025. “Il libro L’affare umano. Al di là della paura di morire (Meltemi) di Luc Dardenne – si legge nella motivazione – si distingue per la capacità di intrecciare linguaggio artistico e indagine filosofica, affrontando con originalità e profondità le grandi domande esistenziali legate alla morte di Dio, al senso del limite e alla paura della fine”.
Nel libro L’affare umano lei prende le mosse dalla “morte di Dio” come evento simbolico che costringe l’uomo moderno a ripensarsi...
«La “morte di Dio” di cui parlo riguarda la nostra condizione di esseri umani privati del sostegno e della consolazione di cui uno dei nostri affetti fondamentali -la paura- ha bisogno per permetterci di vivere. Una paura che, in fondo, è sempre paura di morire. Siamo esseri umani composti da due dimensioni bio-psichiche: da un lato la lotta per vivere - il nostro conatus essendi - e dall’altro la richiesta di un aiuto esterno per vivere, per ottenere cibo, affetto, riconoscimento e sicurezza. In fondo, tutto questo è un modo per cercare di placare la nostra paura di morire. Ma se ci viene tolto quel Dio, grande e infinito dispensatore di amore e di sicurezza, capace di lenire la nostra paura della morte, come possiamo continuare a vivere? Possiamo scegliere di non riconoscere lo stato di solitudine e paura in cui ci lascia la sua scomparsa, illudendoci di essere forti e potenti, capaci di negare la nostra mortalità».
Lei distingue tra la “paura di morire” e la “paura della morte”. Può spiegarci la differenza e perché questa distinzione è decisiva per comprendere la condizione umana contemporanea?
«Paura della morte significa che esistono ancora rappresentazioni capaci di tenere la morte a distanza, di inscenarla, di attribuirle un senso; ci fanno credere che la morte sia un passaggio, una fine non definitiva. Uno dei compiti delle credenze religiose è proprio quello di attenuare la brutalità del morire. La paura di morire è il contatto diretto con quel fatto brutale, impossibile da vivere per l’essere umano privo di rappresentazioni della morte. Oggi, il rapporto solitario e ossessivo che l’individuo intrattiene con il proprio corpo - un corpo giovane, potente, che nega l’età e la mortalità - è il sintomo di questa assenza di rappresentazioni della morte di fronte al fatto di morire, e anche della solitudine nuda dell’essere umano senza Dio, spaventato dalla propria fine e che tenta invano di rassicurare sé stesso inventandosi un corpo immortale».
L’affare umano è scritto da chi è, prima di tutto, un regista. Tuttavia, contiene pochissimi riferimenti diretti al cinema. In che modo l’arte – e il suo mestiere – dialogano con le sue riflessioni sull’umano?
«Riprendendo le parole di Patrice Loraux, direi che l’arte può offrirci delle “superfici di pura sensibilità” o forse, nel caso del cinema, dovremmo parlare di flussi di pura sensibilità, capaci di risvegliare in noi la sensibilità e la tenerezza verso l’altro. Nel nostro ultimo film abbiamo cercato di filmare i corpi, i gesti, gli sguardi, le parole e i silenzi dei neonati, delle madri e delle educatrici in modo da tessere una superficie di pura sensibilità, lasciando scorrere un flusso di pura sensibilità.
Nei suoi film spesso dà voce agli ultimi, a chi vive ai margini. Nel libro parla della “sofferenza innocente”. Qual è, per lei, la responsabilità dell’artista e dell’intellettuale di fronte al dolore altrui?
«La nostra responsabilità - mia e di mio fratello - è quella di filmare individui che possano apparire per ciò che sono: esseri unici, non rinchiusi nella loro caricatura né ridotti alla loro immagine. Come ricorda Emmanuel Lévinas, bisogna evitare di scomparire nella propria immagine. Quando filmiamo gli esclusi e le escluse delle nostre società, il nostro sguardo non deve trasformarli in “casi sociali” o in semplici vittime: vogliamo che restino persone uniche, vive, irriducibili alla loro condizione o ai pregiudizi dello spettatore. Il loro dolore e la loro sofferenza appartengono solo a loro, non devono farsi immagine né tanto meno diventare spettacolo, ma restare refrattari a ogni inquadratura che tenti di sottrarre loro quello sguardo che continua a guardarci».
A Udine sarà proiettato Giovani madri. Com’è nato questo nuovo progetto?
«Il film è nato dal nostro incontro con una casa rifugio per ragazze madri, che abbiamo visitato per documentarci. La protagonista era una giovane madre che viveva in una struttura di accoglienza e non riusciva a entrare in contatto con il proprio bambino. Siamo tornati più volte in quella casa - la stessa dove poi abbiamo girato le riprese - e, a poco a poco, siamo stati catturati da ciò che vi accadeva e dalle persone che vi vivevano: sole, eppure profondamente legate tra loro. È stato proprio questo incontro a far nascere in noi il desiderio di realizzare un film corale, abitato da più personaggi e da una pluralità di voci e di sguardi».
Il suo cinema, intimo e posato, sembra opporsi ai blockbuster hollywoodiani che spopolano nelle sale di tutto il mondo. Cosa ne pensa al riguardo?
«Il cinema è un’arte di straordinaria varietà, capace di esprimersi in forme molto diverse tra loro. Direi che, oggi come in futuro, ciò che importa è che la grande macchina commerciale dei blockbuster e delle serie iper-sceneggiate non soffochi gli sguardi unici dei cineasti, quelli che sanno guardare il mondo, amarlo e insieme criticarlo, e che nei loro film continuano a testimoniare una bellezza e una sincerità essenziali per vivere come esseri umani desiderosi di comprensione e, lasciatemi dire, d’amore».
Tra gli eventi di oggi del festival, alle 17 nella Torre di Santa Maria, “I linguaggi degli algoritmi”: Riccardo Manzotti, Giovanni Boniolo in dialogo con Andrea Colombo; Alle 18, alla libreria Tarantola, un incontro con Massimo Donà dedicato a “La filosofia di Lucio Battisti”
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








