Lo scrittore sale in carrozza: viaggio sui treni letterari italiani
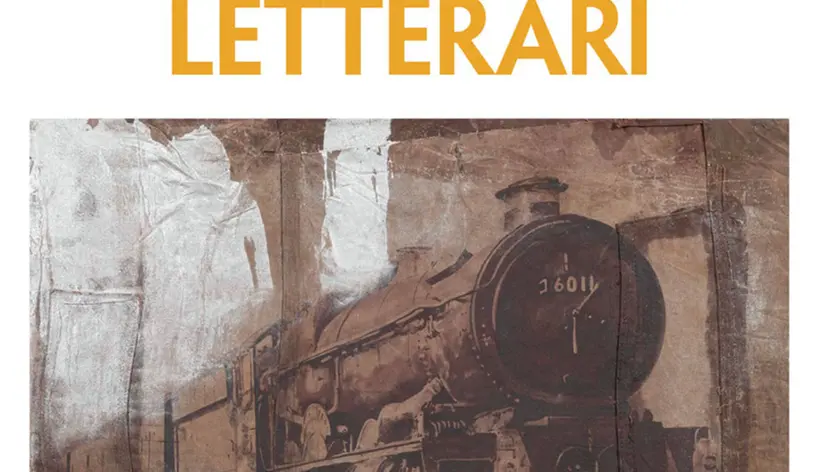
Appuntamento dedicato alle ferrovie storiche del Friuli Venezia Giulia domani, mercoledì 10, alle 18 sulla webtv e sul canale Youtube dell’associazione La Prora, con l’intervento di Romano Vecchiet, già dirigente del Servizio integrato musei e biblioteche del Comune di Udine, appassionato storico delle ferrovie in Friuli e autore di numerose pubblicazioni, che qui recensisce un recente volume dedicata al tema.
* * *
Se persino la contessa contadina per antonomasia, Caterina Percoto – ricordata in nota nel saggio di Beatrice Laghezza e Stefano Lazzarin – si lasciò sedurre dalla novità del viaggio in treno, tanto da disseminare i suoi racconti di diversi riferimenti ai viaggi “in vapore”, figuriamoci Carducci, Verga, Pirandello e i futuristi, che del treno vissero qualche anno dopo l’epopea più alta, quando per spostarsi non esistevano altri mezzi se non i convogli che correvano lungo le strade ferrate di mezza Europa, quali innumerevoli e diverse attestazioni ci lasciarono!
Per meglio capire come il treno sia entrato nelle pagine di molti nostri narratori e poeti, e come in molti casi ne influì la stessa struttura narrativa, dopo lo splendido volume di Remo Ceserani, “Treni di carta.
L’immaginario in ferrovia: l’irruzione del treno nella letteratura moderna”, uscito ormai nel lontano 1993, oggi il lettore italiano ha un’altra opera di riferimento che, se non può mantenere la coerenza metodologica della ricerca di Ceserani, affidata com’è a ben venti studiosi perché esito di uno specifico convegno di studi, è comunque uno strumento di grande interesse e, in un certo senso, completa la ricerca di Ceserani: parliamo di un corposo volume di oltre 400 pagine dal titolo Treni letterari. Binari, ferrovie e stazioni in Italia tra ’800 e ’900, a cura di Giovanni Capecchi e Maurizio Pistelli, edito a Torino da Lindau (464 pagine, 32 euro).
Il libro illumina su nuovi aspetti del rapporto treno - letteratura sia in alcuni autori per i quali Ceserani si era già pronunciato (per esempio Carducci, Svevo e Pirandello), ma soprattutto in nuovi autori italiani del Novecento che Ceserani non aveva ancora preso in considerazione, come Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Dino Buzzati, Marcello Venturi, Elio Vittorini, Anna Maria Ortese, Carlo Cassola e diversi altri.
L’opera affronta anche aspetti “ferro-letterari” da angolature nuove e originali, come la guidistica (con Stefano Pifferi, che giustamente non poteva non iniziare con Carlo Collodi e il suo pionieristico Un romanzo in vapore del 1856, vera e propria guida turistica per i primi utilizzatori della Firenze-Livorno), o i treni e la guerra (con il bel saggio di Vittorio Roda, che non dimentica né i treni dei coscritti dei Malavoglia di Verga, afflitti da “un’oscura inquietudine”, né quelli dolenti della Shoah di Primo Levi), o quello su narrativa investigativa e immaginario ferroviario di Maurizio Pistelli, corredato da un’iconografia editoriale molto inusuale e preziosa, o quello, inedito per l’originale impostazione, intitolato Treni inquietanti e fantastici di scrittrici italiane dei già ricordati Laghezza e Lazzarin, con protagoniste la futurista Rosa Rosà, Anna Maria Ortese ed Elsa Morante, per finire con due saggi molto stimolanti, quali quello che lega il lavoro alla rappresentazione ferroviaria di Carlo Baghetti (studiati, tra gli altri, Paolo Volponi e Nanni Balestrini) e, proprio dulcis in fundo, Treni turistici di Giovanni Capecchi, che del treno offre un’immagine ormai del tutto svanita, quella del mezzo di trasporto per le mete delle nostre vacanze, con una carrellata che, partendo dall’obbligato Lorenzini/Collodi in viaggio da Firenze al mare di Livorno, non trascura Eugenio Montale e la poesia delle Cinque Terre per finire malinconicamente con Aldo Palazzeschi e il suo Doge, dove il turismo ferroviario è già turismo di massa, “che invade – vociante, superficiale e incolto – la città della laguna”.
Un capitolo a sé ce lo offre infine Fulvio Senardi, con il denso saggio Treni e letteratura a nord-est, che analizza con particolare attenzione il Corto viaggio sentimentale di Italo Svevo, giustamente ritenuto a pieno titolo una delle poche opere compiutamente ferroviarie della letteratura italiana.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








