La morte di Pasolini: «Fu ucciso perché conosceva i segreti di piazza Fontana»
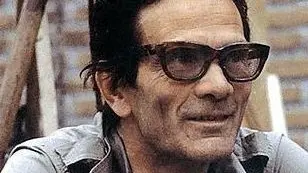
Quarantacinque anni fa, la notte tra il 1 e il 2 novembre, Pier Paolo Pasolini viene barbaramente ucciso all’idroscalo di Ostia. Un “massacro tribale”, così la giornalista Simona Zecchi, su cui si sono versati fiumi d’inchiostro, indagini e processi che mai hanno fatto completamente luce sulle vere ragioni di quel “massacro”, i suoi mandanti e i suoi esecutori.
Liquidato come un delitto a sfondo sessuale, l’omicidio del poeta di Casarsa nasconde ben altre verità. Sulle quali Simona Zecchi è tornata due volte. La prima nel 2015 con “Pasolini Massacro di un poeta! (Ponte alle Grazie editore)in cui avvalendosi di una nutrita testimonianza anche fotografica, smonta le varie spiegazioni di quel delitto dimostrando la matrice fascista dell’agguato, la direzione dell’intelligence nostrana, i tentativi di alcuni giornali di trasformare Pasolini in imputato nello stesso processo che avrebbe dovuto stabilire l’identità dei suoi assassini.
Ora è da pochi giorni in libreria, sempre per Ponte delle Grazie, con L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini, in cui, sempre attraverso una ricostruzione documentatissima, si dimostra la fondatezza delle conclusioni cui era arrivata nel volume precedente. In particolare il fatto che, dietro le stragi di Stato, ci fosse apparati dello Stato e la destra neofascista, fautori di quella strategia della tensione che avrebbe dovuto portare a un nuovo regime in Italia. Stragi, a partire da quella di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre del 1969, sulle quali Pasolini stava lavorando nella sua veste di “giornalista d’inchiesta”, ostinatamente, e per lui necessariamente votato alla ricostruzione della verità storica, epperciò sempre più scomodo sia a destra che a sinistra.
Infatti, ci dice Zecchi, «due settimane prima della morte, Pasolini viene a conoscenza di una corposa documentazione, un dossier che dimostra il segreto politico dietro la strage di Piazza Fontana. Segreto che coinvolge Mariano Rumor, presidente del consiglio in carica quando scoppiano le bombe del 12 dicembre (che sono soltanto una parte del piano di destabilizzazione). Pasolini, che dal 1969 cercava la verità su Piazza Fontana e che fra il 74 e il 75 ribadisce questa intenzione perché prende atto della strategia destabilizzante in corso, muore assassinato da giornalista. A un anno da “Io so, non ho le prove” infatti (articolo che scrive nel 74) lo scrittore ottiene quelle prove e le avrebbe pubblicate. Sono gli articoli pubblicati fra il marzo e l’ottobre del 75 la spia di quello di cui era venuto a conoscenza. Stesso periodo dello scambio epistolare fra Giovanni Ventura, esponente della destra eversiva e Pasolini».
In quel tentativo di coinvolgere Pasolini e usarlo come cavallo di Troia nella denuncia contro la Dc e i suoi esponenti più di spicco. «Lettere che i due si sono scambiati – ancora Zecchi – che assieme alle carte da me trovate in casa Ventura servono a ricostruire l’invio di questa documentazione riguardante i finanziamenti alla Dc che la Cia erogava, parte dei quali sono serviti alla cordata imprenditoriale politica per alimentare il piano della strategia della tensione».
Documentazione che illustrava il ricatto politico, che come Zecchi dimostra ci fu, da parte di Ventura e i suoi collaboratori che «mirava a far scoppiare tutto: ovvero il collegamento fra Rumor la sua cordata politica degli anni ’69-’75 e l’appoggio alle stragi. Rumor infatti rischiò di essere ammazzato da Ordine Nuovo per non aver proclamato lo stato di emergenza dietro le bombe dello stesso 12 dicembre. Piano al quale era legato proprio per via di quei finanziamenti che dimostro».
L’invio di questa documentazione viene effettuato attraverso una strategia di accerchiamento messa in campo da Freda (altro esponente della destra eversiva) e Ventura verso il mondo della sinistra culturale e politica e ben orchestrata come strumento della strategia della tensione.
L’altro dato molto interessante, e per molti versi ancora sconosciuto, che emerge dal lavoro di Simona Zecchi è il rapporto tra sinistra e strategia della tensione e l’atteggiamento a dir poco di sufficienza di esponenti della sinistra nei confronti di Pasolini. Così Zecchi: «Il lavoro di inchiesta di Pasolini era anche quello che mirava a capire cosa c’era dietro i finanziamenti verso la sinistra da parte della destra imprenditoriale. Lo dimostra un suo articolo uscito solo postumo sebbene datato 1973. Il Gruppo 63 viene coinvolto in questo piano di destabilizzazione culturale parallelo e affine a quello stragista».
Un’indagine, quella di Zecchi, che offre un quadro molto articolato della storia di quegli anni, sulla quale Pasolini stava lavorando in quella che considerava la sua nuova missione di intellettuale testimone e interprete del suo tempo, e che gli costò a lui la vita e a noi il nascondimento per decenni della verità. —
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








