Il compleanno del movimento che volle speciale la nostra regione
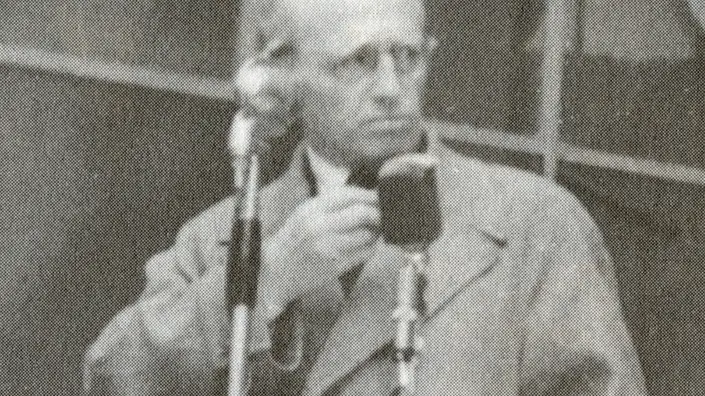
Il primo segnale di una nuova ondata autonomista, parallela ma piú radicale di quella sollevata da Tessitori con la fondazione dell’Associazione per l’Autonomia Friulana, avvenuta il 29 luglio 1945 nell’osteria “Alla buona vite” di Udine, apparve il 24 febbraio del 1946 con il primo numero de “La Patrie dal Friul”, che fu tribuna di don Giuseppe Marchetti. Poi Tessitori, eletto all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946, fu assorbito dagli impegni di Roma, ed ebbe poco tempo da dedicare all’Aaf, che alcuni consideravano “morta”.
Gianfranco D’Aronco a pagina 97 di “Friuli regione mai nata” scrive testualmente: «L’Associazione per l’autonomia friulana, come si è visto, si era limitata alla pubblicazione di qualche articolo e opuscolo. Il Tessitori era evidentemente convinto dentro di sé che conveniva puntare prevalentemente su un’azione a Roma e che, lanciata l’idea, non era prudente agitarla troppo.
Potevano nascere, da parte di interessati contrari, reazioni pericolose. Meglio dunque un’azione sotterranea. Noi invece scalpitavamo. E volevamo non sostituire, ma affiancare l’Associazione, dando forza all’operato condotto al centro dai parlamentari, in primo luogo dal Tessitori stesso».
Nell’appunto (spedito dal D’Aronco ad alcuni amici nell’agosto ’46) accennavamo alla necessità da un lato di tenere le distanze dagli autonomisti piú radicali, dall’altro di predisporre una bozza di statuto, che contemplasse il solo Friuli Regione autonoma (la Venezia Giulia era al momento praticamente avulsa). «I consensi furono immediati e incoraggianti: i giornali parlavano della Sicilia e della altre regioni, mentre sul Friuli praticamente si taceva».
Le parole di D’Aronco trovano conferma nel libro dei verbali del Mpf, nel quale si legge che l’idea di un nuovo Movimento piú dinamico fu concepita ai primi di settembre 1946 in un incontro svoltosi a Tricesimo durante le manifestazioni della settimana della friulanità.
Ferveva nel frattempo in Friuli la polemica contro gli autonomisti, che si difesero efficacemente sui giornali (memorabili alcune risposte taglienti del giovane Pasolini), fecero votare un importante ordine del giorno favorevole all’autonomia dal Congresso della Società filologica friulana a Spilimbergo, e compilarono un volume, intitolato “La Regione del Friuli”, che a metà dicembre fu distribuito ai membri della Seconda Sottocommissione della Costituente.
Raggiunsero cosí un primo importante risultato: nella seduta del 18 dicembre con 17 voti contro 10 (contrari socialisti e comunisti) la Sottocommissione decise di condere al Friuli l’autonomia regionale, con Udine capitale.
La regione, senza il Mandamento di Portogruaro, doveva tuttavia accogliere le terre non friulane assegnate all’Italia dal trattato di pace, e per questo l’onorevole Uberti propose di chiamarla Friuli-Venezia Giulia, ma la Sottocommissione preferí chiamarla “Giulio-Friulana” (denominazione, scrisse Pasolini su “Libertà” il 26 gennaio 1947, «veramente di pessimo gusto, se non altro linguistico»).
La formula, ambigua e insoddisfacente, lasciava aperta la questione delo statuto, cioè, in pratica, la risposta alla domanda: “Quale (e quanta) autonomia?”, e Gianfranco D’Aronco accelerò i lavori di fondazione del Movimento popolare friulano, che si presentò all’opinione pubblica con un manifestato datato 12 gennaio 1947.
In quello stesso giorno al “Malibran” di Venezia, Luigi Ciceri e Chino Ermacora difesero il progetto dell’autonomia friulana in una surriscaldata assemblea veneta che non voleva perdere il Friuli, ancora visto come un lembo della Terraferma prenapoleonica.
Si arrivò cosí al trionfale comizio di fondazione, che si svolse domenica 19 gennaio nell’affollatissimo teatro “Puccini”. Sotto la presidenza di Chino Ermacora, parlarono Gianfranco D’Aronco, Alessandro Vigevani, Etelredo Pascolo e Mario Livi, applauditissimi. Fischiati e interrotti, invece, Giovanni Colonnello, comunista, che definí le autonomie pericolose per l’unità nazionale (!), e l’avvocato Anzil, venuto da Venezia per ricordare la pericolosità dello smembramento del Veneto e l’inadeguatezza del Friuli a essere Regione.
Scopo del Movimento, recitava l’articolo 2 dello statuto, «è ottenere la ricostruzione integrale della Regione del Friuli nei suoi confini naturali con la piú ampia autonomia, entro l’ambito dello Stato italiano». (A pensarci bene, è ancora un progettovalido dopo settant’anni).
Poi gli eventi si susseguirono velocemente. Il primo febbraio 1947 la Commissione del 75 «in attesa di accertamenti», decise di rinviare ogni decisione sulle “regioni non storiche” (il Salento, il Molise, l’Emiliana-Lunense e la Lucania), e solo per l’intervento del trevigiano Cevolotto e del presidente Meuccio Ruini fu lasciata aperta la porta al “Friuli-Venezia Giulia”.
Tutto fu deciso, infine, il 27 giugno, quando Tessitori, per strappare il Friuli al Veneto (regione storica), propose un emendamento all’ordine del giorno Pecorari, che voleva aggiungere alle regioni a statuto speciale previste dall’articolo 108 la regione “Giulio-Friulana e Zara”. Tessitori propose di eliminare “e Zara” (il Trattato di pace era stato firmato il 10 febbraio 1947) e ottenne il voto della maggioranza.
Il Movimento non si sciolse, dopo quel voto, per la buona ragione che rimaneva aperta la questione dello statuto, da elaborare in fretta perché tutti credevano che si sarebbe votato nel 1948. In ottobre, invece, fu votata la X norma transitoria che ibernò la nostra Regione per quindici anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








