Friuli Storia, terra irredenta: Fabio Todero è il secondo autore finalista del premio
La Grande guerra al confine orientale e l’inferno del Carso. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si terrà a Udine il 26 ottobre
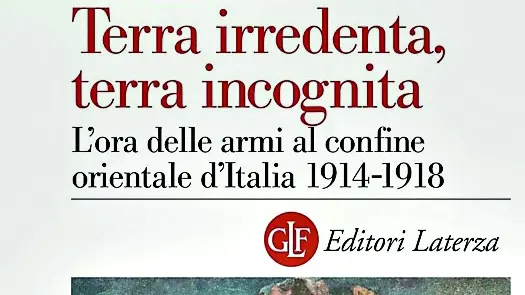
“Terra irredenta, terra incognita. L’ora delle armi al confine orientale d’Italia 1914-1918” (Laterza 2023) di Fabio Todero, è il secondo dei tre saggi finalisti della XI edizione del Premio Friuli Storia (gli altri sono quelli di Filippo Triola, che abbiamo presentato la settimana scorsa, e di Sergio Luzzatto, in programma la prossima). Sancirà il vincitore una giuria di 403 lettori, che voterà fino al 31 agosto. La cerimonia di premiazione si terrà a Udine il 26 ottobre.
*****
Quando nei Malavoglia si nomina Trieste, viene evocato un «lontano» di cui si conosce il nome, ma che rimane quasi indistinto. Trieste terra «incognita», allora: così la cartografia antica indicava un territorio inesplorato che – osserva Fabio Todero – «la fantasia poteva popolare a proprio piacimento».
Allo scoppio della Grande Guerra, oltre quattro decenni dopo l’uscita del romanzo di Verga, lo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie aveva accorciato molte distanze, ma per tanti italiani l’unica occasione di viaggio nell’arco di un’intera vita era ancora la partenza per il servizio militare. Trieste, nel frattempo, aveva formato con Trento «un binomio destinato a enorme fortuna»: parole chiave dell’interventismo, certo, ma anche uno slogan o poco più per la gran parte degli italiani; di fatto, «la causa e la meta di una guerra le cui ragioni erano difficilmente comprensibili».
La “Venezia Giulia” fu sia l’epicentro della Grande Guerra sia l’oggetto di una grande costruzione mitopoietica. L’espressione, coniata da Graziadio Isaia Ascoli nel 1863, non ebbe immediata fortuna, non fu universalmente accettata e ciò creò sconcerto anche in chi aveva competenze geografiche. Peraltro – annota l’autore – benché la regione autonoma Friuli Venezia Giulia esista dal 1963, persino la stampa più autorevole fatica ancora oggi a capire che cosa si intenda per “Venezia Giulia”, e non pare che il Giorno del ricordo abbia arrecato sostanziali progressi a questo proposito.
La denominazione scelta da Ascoli per il territorio del Litorale austriaco (la provincia imperiale che racchiudeva la Principesca contea di Gorizia e Gradisca, la Città “imperiale” di Trieste e il Magraviato d’Istria) intendeva sottolineare la continuità storica, linguistica e geografica con il Veneto, prossimo all’annessione, e con il Trentino. Ma i nostri connazionali mandati a combattere nella Venezia Giulia conobbero un territorio multietnico, con popoli che operavano altre spinte per la costruzione di Stati di elezione e che vivevano la guerra «con animo contrastante, specie quando l’Italia decise di parteciparvi»: una «babele di uomini in divisa che si affrontarono nelle trincee del Carso e sulle vette delle Alpi Giulie, sulle colline del Collio e nella valle dell’Isonzo», nel quadro di una «guerra totale» che infierì anche su «una cittadinanza sempre più sotto assedio».
Raccontando la rappresentazione della Grande Guerra al confine orientale, il libro offre una panoramica di una realtà estremamente complessa, ricostruita usando fonti varie e copiose: oltre alla nutrita bibliografia troviamo testimonianze, memorie, diari, canti, cronache dell’epoca, testi letterari e di riflessione politica…
Grazie a tutto ciò, il lettore percorre sentieri plurimi, ma comunicanti: le diverse posizioni dell’irredentismo, il progredire e consolidarsi dei processi di nazionalizzazione, gli obiettivi dei liberal-nazionali, lo sviluppo del movimento socialista, le difficoltà dell’esercito austro-ungarico, le vicende dei triestini combattenti con l’Impero e di quelli che scelsero l’Italia, gli ostacoli incontrati dai volontari, i fronti lontani come la Galizia, «cimitero dei popoli», e quelli vicini, e poi le odissee del ritorno, gli spostamenti di massa di popolazioni, i nuovi ruoli e l’inedita dimensione politica delle donne, la tormentata fase di uscita dalla guerra della regione Giulia, la questione adriatica, la brutalizzazione della politica, le politiche della memoria, il fascismo di confine, e così via.
Pagine di particolare intensità dipingono l’inferno del Carso, dove si scontrarono italiani, austro-tedeschi, sloveni, croati, rumeni, ungheresi, bosniaci, ruteni… Anch’esso un «cimitero dei popoli», mitizzato e trasfigurato dalla propaganda ma, nella realtà, una dimensione bellica primitiva mescolata con la terrificante novità della guerra moderna.
Di fronte al conflitto in Ucraina, infine, Todero non ha potuto esimersi da riflessioni come questa: «Ciò che credevamo alle nostre spalle si è riproposto nella nostra Europa e proprio in terre dove tanti uomini provenienti dalla Venezia Giulia hanno affrontato la guerra più di cent’anni fa».
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








