Liliana Segre: «Vi racconto l'incubo del lager e la mia infanzia perduta»
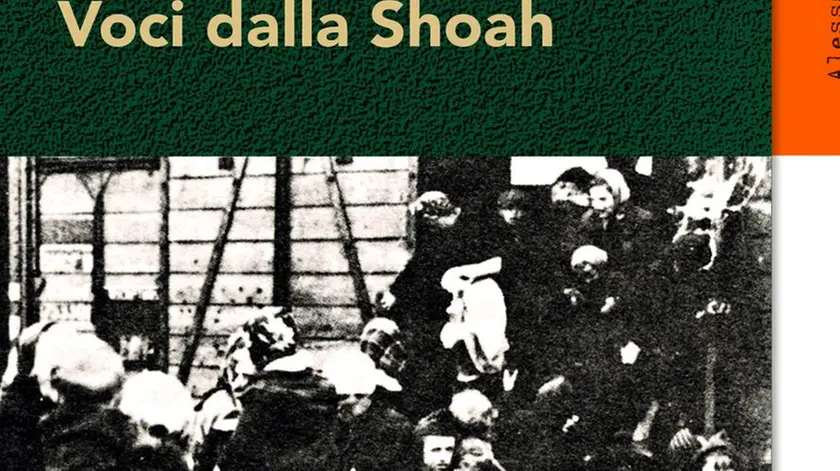
Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore Gaspari, un estratto della testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, contenuto nel volume “Voci della Shoah”, curato dal giornalista Claudio Facchinelli.
***
Quando vado a parlare nelle scuole e cerco di trasmettere ai giovani la memoria di quanto ho visto e sofferto cinquant’anni fa nei campi di sterminio nazisti, ricordo sempre una frase che dice che il mondo non è stato più lo stesso dopo Auschwitz. E questo riguarda tutti.
E noi, noi che Auschwitz lo abbiamo sulla nostra pelle e dentro i più intimi recessi della nostra mente? Noi come abbiamo potuto e possiamo vivere? Come può il nostro cervello reggere ai ricordi senza impazzire, come può ricordare i visi, i colori, i suoni, gli odori senza esserne soverchiato e perduto?
Come possiamo camminare per le strade del mondo, della città, guardarci intorno e allo specchio senza vedere una realtà deformata dalla nostra esperienza, con la paura di risvegliarci dal sogno e ripiombare in quell’orrore?
Invece, la nostra vita «dopo» Auschwitz ha ripreso a scorrere all’«apparenza» su binari comuni agli altri nostri contemporanei: ridiamo, piangiamo, camminiamo e mangiano, abbiamo letti, tavolo, telefono, libri, fiori, musica, casa, amore, un gatto, una bella fotografia di tutta la famiglia!
Ma, come eravamo allora?
Io ero una bambina di 8 anni, orfana di madre, quando mio papà mi spiegò con dolcezza che in quell’autunno non sarei più potuta andare alla mia scuola (pubblica) perché ero una bambina ebrea e c’erano delle nuove leggi che mi impedivano di continuare la mia vita di prima.
Quel momento, eravamo a tavola, è il momento che divide la mia infanzia tra «il prima e il dopo».
Ricordo tre visi ansiosi che mi guardavano: il mio papà, il nonno Pippo e la nonna Olga.
Era il 1938: cominciava la persecuzione, eravamo diventati cittadini «di serie B». Incontravo qualche volta le mie ex compagne di scuola; erano bambine che, avendo sentito parlare i loro genitori, mi segnavano con il dito e le sentivo dire: «Quella è la Segre, non può più venire a scuola con noi perché è ebrea».
Non sapevano bene neanche loro quello che voleva dire e tutto sommato non lo sapevo neanch’io. Famiglia agnostica la mia, non frequentavamo né la Sinagoga né ambienti ebraici. Fu ancora più difficile accettare la realtà delle leggi razziali. (...)
Quando, dopo l’8 settembre 1943, i tedeschi occuparono l’Italia del Nord, furono le leggi di Norimberga a condannarci. Mio papà decise di mettere in salvo me. Avevo i documenti falsi e facevo gran fatica ad imparare le nuove generalità. Fu terribile lasciare (e per sempre) la mia casa ed i miei nonni. (...)
Nel novembre 1943 i nonni ebbero il permesso dalla questura di Como di risiedere ad Inverigo, sotto la responsabilità dei padroni di casa; il nonno era un malato terminale del morbo di Parkinson e la nonna era debole e smarrita. Mio papà credette in quel permesso e decise di partire con me. I nonni furono poi deportati nel maggio successivo e uccisi al loro arrivo ad Auschwitz.
Partimmo: Legnano, Varese, Viggiù, Saltrio, le montagne verso la Svizzera. (...) Con fatica enorme, passammo il confine sulle montagne dietro a Viggiù, e arrivati in Svizzera ci pareva di sognare. Pochi passi in un bosco, bagnati e intirizziti (era il 7 dicembre 1943), poi ci imbattemmo in una sentinella che ci accompagnò al comando di Arzo (piccolo paese del Canton Ticino).
Là un ufficiale svizzero-tedesco, subito odioso, non volle sentire né ragioni, né suppliche, né pianti (miei), anzi mi allontanava con un piede quando, inginocchiata per terra, lo supplicavo di tenerci in Svizzera e dicendoci sgarbatamente che eravamo degli impostori, ci rimandò indietro scortati da sentinelle armate e sogghignanti.
Era il pomeriggio di quella giornata eterna e piena di emozioni: di nuovo sulla montagna cercando un passaggio, io toccai la rete di confine e una suoneria suonò forte e squillante nel silenzio invernale. Arrivarono due finanzieri italiani, mio padre e due cugini decisero di rientrare in Italia sperando nella pietà di qualcuno, invece fummo arrestati.
La sera stessa dormimmo tutti e quattro nella camera di sicurezza della caserma dei finanzieri e il giorno dopo fummo portati a Varese in automobile con le SS. Guardavo ipnotizzata e impietrita i polsi di mio papà con le manette, non osavo guardarlo in faccia!
Il carcere
Entrai da sola a 13 anni nel carcere femminile di Varese e dopo l’iter della foto e delle impronte digitali, eccomi a seguire piangendo la sagoma scura di una guardiana lungo un corridoio: mi fece entrare in una grande cella che condivisi per cinque giorni con altre donne ebree; poi fui sempre da sola nel carcere di Como.
Piangevo giorno e notte disperatamente, così quando, dopo otto giorni, fummo trasferiti a San Vittore a Milano, fui addirittura contenta perché li ero con il mio papà. Il quinto raggio era stato destinato agli ebrei: uomini, donne, vecchi, bambini, neonati, eravamo tutti ammassati in attesa della deportazione annunciata. Si facevano mille ipotesi, ma nessuno sapeva che cosa sarebbe successo e quando. (...)
Alla fine di gennaio un implacabile appello di circa 650 nomi scandì anche i nostri. (...) Tutti noi chiamati ci preparammo a partire per quel viaggio verso il nulla. La mattina del 30 gennaio 1944 eravamo una lunga fila di gente muta e attonita che, uscendo dal quinto raggio, ne attraversava un altro per uscire dal carcere.
Furono straordinari i detenuti dell’altro raggio: affacciati ai ballatoi davanti alle celle ci urlavano benedizioni ed incoraggiamenti, ci buttavano chi una mela, chi un’arancia. Fu un bagno di grande umanità, di solidarietà e fratellanza.
Caricati su camion attraversammo una Milano deserta e, arrivati alla Stazione centrale, nei sotterranei trovammo pronto per noi un treno merci. A calci, pugni e bastonate in pochi minuti tutti eravamo stati rinchiusi e piombati nei vagoni: i nazisti, aiutati dai loro cani e dai loro servi repubblichini, avevano fatto in fretta il loro lavoro!
Nel vagone, stipato di un’umanità dolente e disperata, un secchio per gli escrementi e un po’ di paglia per terra, né luce, né acqua.
Il viaggio durò una settimana
(...) All’alba del 6 febbraio 1944 il treno si fermò: era Auschwitz.
I nostri aguzzini avevano preparato già da anni una stazione di arrivo per tutti i treni dei deportati dai paesi occupati: era una spianata coperta di neve con dei binari morti. Fine corsa! Era una visione apocalittica: la massa dei nuovi arrivati, disperati, scesa dai vagoni, veniva spinta con violenza da prigionieri rapati e vestiti e righe, a loro volta aizzati dalle SS e dai loro cani lupo.
In un attimo furono divisi gli uomini dalle donne e lasciai per sempre la mano del mio papà. Non sapevo che non l’avrei più rivisto.
Passammo tutti la prima feroce selezione e fui scelta quel giorno insieme ad altre trenta donne; tutte le altre, giovani, vecchie, sane o malate, partirono a bordo di camion dirette alla camera a gas. Non capivo nulla, non capivo il tedesco, non capivo i comandi ed ero sconvolta mentre venivo obbligata a mettermi in fila e a camminare verso il campo di Auschwitz-Birkenau, enorme Lager femminile.
Entrammo nel campo: ero come in trance e vedevo confusamente intorno a me una realtà così pazzesca e orribile da pensare che fosse un incubo. Era invece l’inizio di un periodo che avrebbe segnato, e per sempre, tutta la mia vita.
Fummo spogliate di tutto, denudate e poi rivestite di divise a righe e di stracci, rapate a zero, tatuate: il mio numero è 75190 e la mia nuova identità fu legata a quel numero. Non solo il numero ha sostituito allora il mio nome (aveva lo scopo di cancellare dalla Storia i nomi di milioni di persone), ma è diventato negli anni una parte di me.
Si identifica con il dolore puro, si identifica con la violenta sostituzione del mio ruolo, da figlia di mio papà a disgraziata ragazzina di 13 anni, sola nel Lager. Imparai in fretta che cosa voleva dire Lager. Voleva dire morte-fame-freddo-botte-punizioni; voleva dire schiavitù, voleva dire umiliazioni-torture-esperimenti.
(...) Passai tre volte la selezione nell’anno che fui ad Auschwitz; erano selezioni annunciate: sapevamo che erano condanne senza appello. Nude, nei locali delle docce care ai nostri aguzzini, sfilavamo una per una davanti ad un piccolo gruppo di ufficiali SS, fra i quali c’era anche il famoso dottor Mengele.
Senza pietà venivamo osservate davanti, dietro, in bocca e poi… poi era la sorte che decideva se andare al gas o continuare a vivere… fino alla prossima volta.
Alla fine di gennaio del 1945, all’avvicinarsi dei russi in avanzata, il campo fu fatto saltare dai tedeschi in fuga, e distrutto in gran parte (ma non del tutto), e tutti prigionieri e le prigioniere in grado di stare in piedi furono evacuati verso altri campi, verso il Nord e verso il centro della Germania. (...)
Arrivano i nostri
Arrivarono le prime jeep americane, i soldati buttavano cioccolato, sigarette e frutta secca. Io raccolsi felice un’albicocca, mi sembrò fantastica: ero libera, ero viva ed ero libera. Era il 1° maggio 1945.
Gli americani mi curarono un ascesso sotto il braccio con la (nuova) penicillina, fui fotografata tra le sopravvissute più scheletrite, infatti ero una di quelle che aveva resistito più a lungo.
Una grande massa di prigionieri di guerra, politici e razziali, si trovò nelle condizioni di non sapere come fare per tornare in Italia, in Francia e nei vari paesi da cui ognuno proveniva. Gli americani ci organizzarono nazionalità per nazionalità e finalmente alla fine di agosto potemmo tornare in Italia.
Questa volta la tradotta militare viaggiava con i portelloni aperti e vedevamo sfilare città e paesi della Germania, dell’Austria e poi il Brennero, Bolzano: eravamo in Italia! Da Pescantina con un camion militare arrivai a Milano, c’era con me Graziella Coen, una ragazza ebrea romana; l’autista del camion ci fece scendere sul piazzale della Stazione Nord.
La stazione era stata bombardata, la gente stava riprendendo possesso della città ferita dai bombardamenti. C’erano dei passanti che si fermarono a guardare Graziella e me, i capelli corti, vestite come delle pezzenti, sporche.
Un signore ci chiese chi fossimo e, alla nostra risposta, ci fece l’elemosina: due lire. Non avevamo niente, io mi avviai verso la mia casa di un tempo in corso Magenta, 55. Sotto l’androne il portinaio fermò me e la mia amica, ci respinse come delle accattone. Io timidamente gli dissi: «Antonio, sono Liliana Segre!» e guardai in su le finestre della mia casa, chiusa per sempre.
Ecco che allora lui mi riconobbe, si mise ad urlare come davanti ad un fantasma: scesero tutti gli inquilini, ma di loro che cosa mi importava? Poi arrivarono i miei zii ed i miei nonni materni: baci, abbracci, emozione, ma gli altri, i miei santi martiri non tornarono più.
Cominciò una nuova fase
Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io: una ragazzina reduce dall’inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione.
Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva, ero io che dovevo adeguarmi ad un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di divertimenti e spensieratezza.
Vissi per anni con sistemazioni provvisorie, senza altro conforto che lo studio, nel quale mi buttai a capofitto per recuperare gli anni perduti; ma anche a scuola non riuscivo a comunicare con le mie compagne. Ero profondamente infelice, niente e nessuno era come io avevo sognato nella notte del Lager. Dopo aver tanto lottato per la mia vita, ora avrei voluto essere morta. Furono tre anni molto duri e tristi.
Poi, a 18 anni, incontrai l’uomo che divenne mio marito. Con lui, e per lui, ho cominciato a essere una donna normale anche se con un bagaglio di ricordi struggenti e dolorosi fuori dal comune. Insieme abbiamo costruito il nostro futuro, e i nostri tre meravigliosi figli e i nostri due nipoti Edoardo e Davide sono la più bella risposta alla cultura nazista di morte, perché essi sono la vita!
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto









