Viaggio tra “Pinocchio” e “Cuore”, due libri che educarono gli italiani
Il saggio di Giampaolo Borghello sui capolavori di Lorenzini e De Amicis. Diventarono best seller in anni in cui la grande editoria muoveva i primi passi
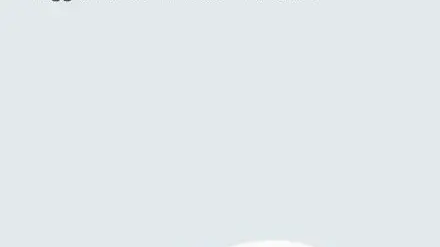
Un paese semianalfabeta, specie nel Sud, in crescita, faticosa e segnato da sommovimenti ribellistici. Uno stato appena assemblato, privo di elementi di unificazione morale e riferimenti valoriali.
Questa l’Italia umbertina, dove vedono la luce, a distanza di soli tre anni, due opere destinate a improntare le generazioni future: Pinocchio e Cuore.
Ne scrive, con penna acuta e brillante, Gianpaolo Borghello, già direttore del Dipartimento di Italianistica dell’università di Udine, in un saggio pubblicato recentemente dalla casa editrice Marsilio: Pinocchio, Attila e oltre – Viaggiando tra Pinocchio e Cuore (il dichiarato riferimento al “flagello di Dio”, con fini temerariamente riabilitativi, parte proprio dalle pagine di Collodi).
I due testi, nota, segnano il passaggio di secolo: «Pinocchio è certamente ascrivibile alla fine dell’Ottocento, mentre si potrebbe pensare, senza troppe forzature, a una collocazione novecentesca di Cuore», e diventano, in modi e tempi diversi, libri di formazione e best seller naturali, in anni in cui la promozione editoriale muove i primi, incerti passi.
Con scrupolo filologico, Borghello analizza una genesi ideativa, un “farsi” e una conquista del mercato che differiscono profondamente.
Carlo Lorenzini, impegnato su molti fronti giornalistici, invia una prima parte di Pinocchio a Guido Biagi amministratore del “Giornale per bambini” scrivendo: «fanne quel che ti pare, ma, se la stampi, pagamela bene per farmi venir voglia di seguitarla».
La pubblicazione a puntate imporrà dei sequel: nella prima tranche (intitolata “Storia di un burattino”, senza ipotesi di redenzione umana) Pinocchio muore sulla forca, ma risuscita causa le proteste che arrivano al giornale. La seconda tranche ha già un lieto fine, con la “festa dei panini imburrati”, però il vivo interesse dei lettori impone un’altra ripresa: Lucignolo, il Paese dei balocchi e quanto ne consegue.
Uscito in volume nella stesura finale, Pinocchio non viene considerato il miglior lavoro di Collodi: dal 1883 al 1897 stamperà 14 edizioni, poi verrà riconosciuto quale capolavoro “scritto per caso” (Pancrazi) o “involontario” (Castellani Pollidori).
Del tutto diverso il percorso di Cuore, scritto da un Edmondo De Amicis “trionfante e sfolgorante” (per autodefinizione), fatto uscire dal triestino Emilio Treves il primo giorno dell’anno scolastico 1886, per assecondarne la scansione narrativa.
In dodici mesi conterà qualcosa come ben edizioni.
C’è del divertissement, ma c’è anche dell’analisi seria, nel libro di Borghello, che confronta il modo in cui vengono trattati il topico conflitto tra il mondo infantile e quello adulto, la valenza emotiva con fini di edificazione (presente soprattutto in Cuore), i diversi registri espressivi, il simbolismo, la scelta di titoli e nomi (per Pinocchio si scomoda di fatto la Gestaltpsycologie).
Presenti anche le critiche, l’«insanabile contraddizione tra una presunta mediocrità testuale e l’enorme successo» (ma la prima non potrebbe spiegare il secondo?), e l’accusa, per Edmondo De Amicis, di «pedagogia piccolo borghese, classista, paternalistica e sadicamente umbertina» (chi non ricorda l’elogio che Eco riserva a Franti, in “Diario minimo”?).
Pamphlet smilzo quanto denso, intensivamente disseminato di note e rimandi, concluso, come recita il titolo, da un’importante postilla sul re degli Unni (nella quale i ragionamenti e la critica sembrano trascorrere in una divertita ironia). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








