Lo sciame, Giovanni Pascoli e le lacrime infuocate del Santo
«San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla», così l’incipit di X Agosto, una delle poesie più celebri di...
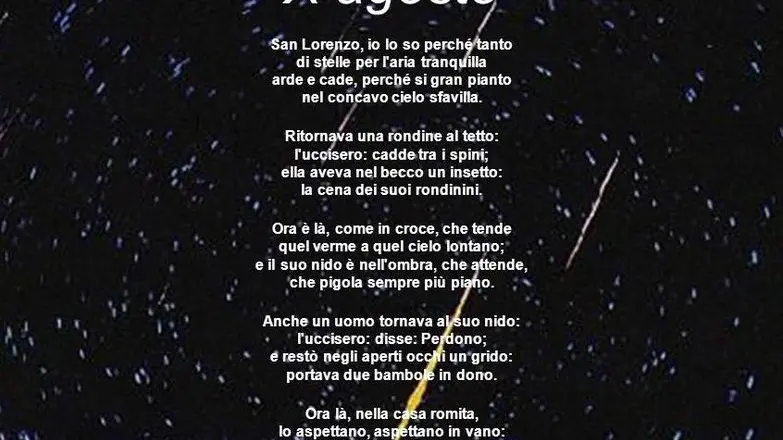
«San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla», così l’incipit di
X Agosto
, una delle poesie più celebri di Giovanni Pascoli, poesia che tutti abbiamo imparato a memoria sui banchi di scuola e che ci ha fatto scoprire sin da piccoli il mistero delle “stelle cadenti” che secondo la tradizione popolare rappresentano le lacrime infuocate di San Lorenzo, arrostito vivo su una graticola di carboni ardenti il 10 Agosto del 258, a 33 anni. Lacrime stellari che dovrebbero illuminare il cielo la notte del 10 agosto. Ma, come da qualche anno a questa parte, il fenomeno, tempo metereologico e luna permettendo, avrà il suo picco e la sua maggior visibilità tra stasera e domani sera. Ma cosa sono in realtà queste che erroneamente chiamiamo stelle cadenti? Si tratta di uno sciame meteorico prodotto dalla Terra che durante il suo tragitto di rivoluzione incrocia nuvole di detriti e polveri lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e orbitante intorno al sole ogni 133 anni. Frammenti e polveri entrano così in atmosfera incendiandosi e dando vita a scie brillanti e fugaci. E’ stato l’astronomo italiano Giovanni Schiapparelli a collegare meteore e cometa. Lo sciame è detto delle Perseidi in quanto lo si vede vicino alla costellazione di Perseo, facilmente individuabile poiché è posta leggermente al di sotto di quella di Cassiopea la cui “W” è assai ben riconoscibile. Fenomeno spettacolare che da sempre, nel cercare di spiegarlo, ha acceso la fantasia degli uomini. E al quale, grazie alla ciclicità del suo accadere, vengono attribuite anche potenzialità magiche o divinatorie: sempre la tradizione, infatti, dice che, se si riesce a formulare un desiderio nel breve lasso di tempo in cui passa la traccia luminosa, questo si avvererà. Una tentazione cui pochi sanno sottrarsi. Ma non sempre è stato così: nell’antichità meteore e comete venivano interpretati anche come forieri di disgrazie e catastrofi, per cui nelle mitologie orientali e in quelle greche e latine, questi fenomeni passeggeri che comunque alteravano l’immobilità della volta celeste, erano letti come lacrime di divinità che piangevano a causa dei malanni già avvenuti o annunciati. Gli astrologi cinesi che avevano registrato nei loro annali apparizioni di stelle cadenti e comete sin dal sesto secolo avanti Cristo, erano addirittura convinti che a temerli dovessero essere soprattutto i governanti: il cielo piangeva lacrime di fuoco per crisi di governo, battaglie e guerre in coincidenza con quelli che oggi sappiamo essere gli sciami meteorici ricorrenti. E quella del pianto celeste fu l’interpretazione, completamente opposta che ne ha fatto la cristianità, trasformandolo in segno di speranza e pietà. Ma forse l’immagine che resta la più forte su questa notte magica, ce la consegna ancora Pascoli nella sua X Agosto, quando in chiusura, dopo aver ricordato per quattro lacrimevoli strofe la morte del padre, assassinato la notte di San Lorenzo del 1857, sconsolatamente e modernamente apostrofa il Cielo che, “dall’alto dei mondi/sereni, infinito, immortale,/ oh!, d’un pianto di stelle lo innondi/ quest’atomo opaco del Male!”
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto
Leggi anche
Video








