Il Novecento di Vittorio Sgarbi tra grandi riscoperte e rivelazioni
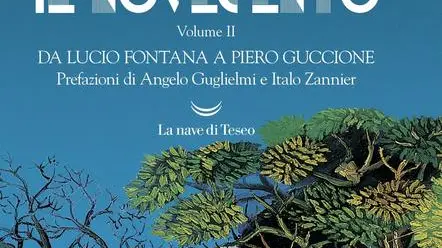
Sarà nelle librerie il 4 aprile, per i tipi di La nave di Teseo, il nuovo libro di Vittorio Sgarbi “Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione”, ultimo e conclusivo capitolo della fortunata serie “I Tesori d’Italia”, con le prefazioni di Angelo Guglielmi e dello storico della fotografia il friulano Italo Zannier del quale pubblichiamo qui la parte introduttiva.
Italo Zannier
Il Grand Tour culturale di Vittorio Sgarbi, nell’implacabile, ma in parte ignoto itinerario dell’arte italiana, giunge ora felicemente, con questo tomo, nel mare di Ulisse che va verso Penelope, forse per intraprendere un altro viaggio, e lo spero, suggerito dall’epocale transito del concetto d’Arte, che sta sottilmente sostituendosi a quello sino a ora vissuto nel suo specifico e lussuoso corpo fisico. Un cosmo fanico – di apparenze – che sta gelidamente istituendosi, quasi all’inconscio generale, mediante le nuove affascinanti e suadenti formule della comunicazione – non soltanto di quella visiva – che il magico “digitale” elettronico, con le sue voraci e globalizzate, tecnologiche ramificazioni, sta penetrando, oltre i nostri occhi e la fisiologica sensibilità tattile, nell’universo onirico dell’Arte, come sintesi logica del nostro millenario percorso sociologico-tecnologico-estetico, retorica a parte, dall’inizio della Storia dell’uomo.
Dopo il luminoso saggio di Peter Galassi, “Before Photography” ci sono sintomi evidenti per la costruzione di un’opera nuova, “After painting”, da avviarsi, ma salvata anche qui, dal passionale, romantico testo di Vittorio. Si è precisata nel nostro tempo una vicenda di transito epocale, che necessita di una coraggiosa presa di coscienza del nuovo passaggio, non come amusement filosofico astratto-masturbante, ma fondamentale tra il tempo del “fatto a mano” e quello del “fatto a macchina”, che ormai è giunto a un punto di non ritorno.
Con questo ampio saggio, finalmente sintetico sulle fonti e sugli autori, privo dei soliti narcisistici esibizionismi accademici, Vittorio Sgarbi ha offerto una oltretutto piacevole occasione di suggerire e far conoscere una congerie di pittori, scultori, architetti, designer, tutti magnifici, che rappresentano il telaio storico-culturale dell’arte del nostro tempo, dall’ultimo dopoguerra a oggi. E senza enfasi ideologiche, ma mediante un civile e appassionato filtraggio esistenziale e romantico degli autori da Vittorio ritenuti esemplari, anche se negli anni sono stati ignorati o sottratti alla fama ufficiale, che meriterebbero, a volte gestita da un collezionismo e da una politica giornalistica diversamente speculativa.
Questo suggestivo saggio di Sgarbi non è un “Dizionario” degli artisti italiani del dopoguerra, guai a cercarli in un ipotetico indice, anche se molti nomi (Afro, Guidi, Tancredi, Zigaina, tra i miei amici di gioventú) sono però qui efficacemente rintracciabili, se non in capitoli specifici, tra le righe intrecciate nelle varie monografie, che nell’insieme sono il “testamento” passionale, oltre che il patrimonio culturale personale del computer Sgarbi. Attraversando il volume, già nelle prime pagine, s’impone la riscoperta del triestino Marchig, e del tipografo Sbisà, accanto al sublime Sciltian, altrove troppo frettolosamente dimenticato, e qui nel confronto con i magistrali Saetti, Vedova (ha il «senso astratto dell’Espressionismo!») o Guttuso (Sgarbi subito cita Arcangeli, suo Maestro, accanto a Testori e Tassi!) e l’inevitabile Lucio Fontana, Piero Manzoni e la Scuola di Milano. Poi gli amati Ligabue («incarna quel genio artistico del popolo, meglio ancora il genio contadino») e l’incommensurabile Balthus, accanto a Mušič («la materia si impasta, ma l’immagine resta di stinta. Sono queste le ceneri di un fuoco acceso molti anni prima da Turner. Ma questo fuoco è anche di Mušič, autenticamente suo»), e Burri ( «reinventa la materia»).
Nel capitolo sull’Architettura e il Design (si poteva aggiungere la Fotografia? ma verrà!? ) eccelle Gio Ponti – invece ingiustamente (ideologicamente) osteggiato e discusso nel dopoguerra (il Pirellone, «un mobile radio in misura gigante», disse allora Zevi ne L’Espresso) –, accanto a Scarpa, De Carlo, Gregotti (un «approccio utopico stabilito con la realtà palermitana») e un esaustivo elenco di designer e “prospettisti”: Bellini, Sottsass, Zanuso, e afferma la complessa opera di Portoghesi, Aldo Rossi, Purini, Piano.
Tra gli incontri nei suoi viaggi nell’amato Veneto, appare Neri Pozza, qui come scultore, in quanto tale però ignoto nelle altre storie dell’arte nostrana, e Sgarbi lo descrive come fosse «un bel racconto di gioventú». Cremonini, che qui, nelle immagini, sembra un fotografo (Franco Fontana? ) però ha dipinto a mano e quindi non lo è. Guarienti e Annigoni sono ancora una volta salvati da Sgarbi, specialmente sottratti alla snobistica e in effetti paradossalmente reazionaria politica culturale nostrana. Autori vincenti però, per la loro estrema e quasi “antica” abilità tecnica manuale, apparen– temente fuori del loro tempo, ma spesso immancabili poeti. Un forte capitolo per Domenico Gnoli, da sempre evidenziato nella saggistica di Vittorio, ma che qui si segnala per il pionierismo Pop, stimolato proprio dal dettaglio “fotografico” ingrandito, come appare in molte opere.
«Da quanti anni non vedevamo poesia? Dopo Morandi, dopo Licini, dopo de Pisis» si esalta quasi a voce Vittorio, citando Piero Slongo, Massimo Rao, Gustavo Foppiani, tra i meno noti autori, che suscitano qui una legittima curiosità. Non trascura la poco amata Arte povera e la Transavanguardia, movimenti nati «dopo una lunga incubazione cominciata da Duchamp», ed elenca autori emblematici come Kounellis, Pistoletto, Merz, De Dominicis, Kosuth...
Ma, si chiede Sgarbi, «può esistere, in arte, un concetto senza fisicità?». Bella domanda, che sollecita il mio narcisismo di stu dioso specifico della fotografia, e oggi della Fotofania, un mio neologismo, per definire le fanie, apparizioni di immagini-luce sugli schermi del cellulare o del computer, e che, allo scatto di un pulsante scompaiono e si riducono a una complessa e illeggibile equazione matematico-elettronica. Questa non ha Corpo ma forse ha l’Anima di un implacabile fantasma! Il corpo dell’immagine, però, può rinascere con lo stesso pulsante e trasferirsi da astratta equazione a evidenza fanica, e da lì a quella grafica, finalmente per me, sopra un supporto fisico, palpabile e profumato, “diver samente visibile”: la Fotografia. Lì sarà il futuro dell’Arte, per le prossime epocali generazioni, mentre il resto corposo, pesante, ingombrante, degradabile... sarà nuovamente Archeologia, come oggi le misteriose Piramidi e l’avvenenza della Venere di Milo.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








