Dal castello di Udine alle Alpi carniche: i ricordi friulani nelle pagine di Gadda
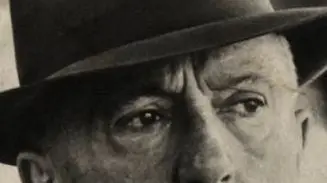
A Udine e allo scrittore Carlo Emilio Gadda è dedicato il nuovo appuntamento del format “Viaggio digitale” di Pnlegge, Regione e Promoturismo Fvg, che sarà online domani, sabato 27, su Fb e Youtube. Protagonista del videoracconto Cristina Benussi, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Trieste, che qui presenta l’iniziativa.
Nel libro di racconti “Il castello di Udine”, pubblicato nel 1934, Carlo Emilio Gadda si concedeva un po' d'autoironia: «sono riuscito a realizzare delle economie sullo stipendio da tenente e con quelle ho finito i miei studi, sono un profittatore di guerra». Sapeva però di avervi ricavato ben altro: partito volontario, deluso poi dalla disordinata gestione militare del conflitto, era stato infine fatto prigioniero. E proprio là, nella baracca tedesca 15 c, aveva riempito le lunghe giornate di reclusione annotando pensieri ed eventi. L'ingegner Gadda insomma era diventato scrittore proprio ricordando le marce e i combattimenti sul fronte delle Alpi Carniche e dell’Isonzo.
Da quel diario, pubblicato postumo come Giornale di guerra e di prigionia, ha poi ricavato, rielaborandoli, alcuni episodi del Castello di Udine: ma in una prospettiva ormai chiaramente letteraria, tale dunque da restituire attraverso la memoria anche il senso della vita. Non a caso lo scrittore vi ha anteposto un excursus sui modi in cui nelle epoche passate, a partire da Roma, venivano condotte le guerre, ovvero da comandanti militarmente preparati, assai diversi quindi da quelli operanti sul fronte friulano; né risparmiava i fanti, erroneamente etichettati dalla voce popolare come "umili". Stabiliva così un parallelismo tra la guerra e la vita, così come allora gli sembrava essere diventata, priva di ordine e di valori condivisi; alludeva anche alla retorica fascista, che solo a parole copriva un innegabile disordine di fondo, etico e conoscitivo. In questo senso Udine diventava il simbolo di una consapevolezza nuova. Durante la guerra, infatti, nella sua stazione ferroviaria avrebbe dovuto incontrare il fratello Enrico, aviatore in transito; ma all’ultimo momento, per un inspiegabile senso del dovere, Carlo Emilio aveva rinunciato alla licenza che gli avrebbe consentito di rivederlo. Poco dopo il giovane morì in un incidente di guerra.
Questo episodio, ricordato nel Castello e poi nella Cognizione del dolore, ha inciso profondamente sulla poetica di Gadda, che in quest'ultimo romanzo ha fatto del dolore la condizione esistenziale attraverso cui vivere il proprio rapporto con la madre e la cerchia dei suoi conoscenti. Lo scrittore non perdonava loro di rimanere legati a una visione superficiale delle cose, senza cercarne i legami nascosti, e risalire alle cause lontane delle proprie scelte. Per amore d'ordine dunque Gadda raccontava trame che si intrecciano sotto i più diversi aspetti, tecnici, scientifici, sociali, simbolici, ecc., usando di volta in volta il lessico di competenza: nasceva così il suo pastiche linguistico che, invece di chiarire, finiva per confermare la complessità inestricabile dell'esistere. La profondità dello sguardo sul dentro, dove si annida il male oscuro, e la ricerca del suo rapporto col fuori, dove regna il caos, hanno fatto poi di Gadda lo scrittore simbolo della neoavanguardia degli anni Sessanta.
Per questo, riandando con la memoria a Udine, la città gli si è rivelata come lo snodo della sua esistenza, la linea d'ombra del passaggio alla maturità. Proprio dal suo Castello si schiudeva la visuale sulle Alpi Carniche, rocce grigie screziate dal bianco del ghiaccio che si stagliavano nel cielo blu cobalto. Là era trascorsa la sua giovinezza, che a Udine, anche se ancora non lo sapeva, sarebbe terminata. Partendo dalla stazione, dove troppo tardi era infine transitato, lo scrittore aveva dunque attraversato tutto il centro e ammirato gli affreschi di Tiepolo, cui nel testo accenna di sfuggita come ad opere magnificamente composte, appartenenti dunque a un mondo diverso da quello caotico della guerra. E così, in una lacerante contraddizione, alla bellezza dell'arte e delle montagne che allora lo incantarono vedeva intrecciarsi inestricabilmente il dolore: o meglio, la “cognizione del dolore”.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








