Da sbirro a detective: un libro ricostruisce la storia italiana dell’investigazione
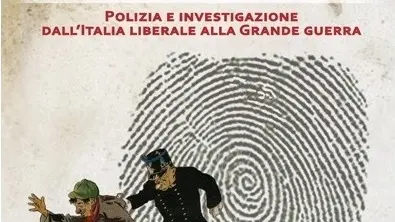
PAOLO MEDEOSSI
Il dottor Francesco Ingravallo, capo della squadra mobile, era di statura media, tozzo, di capelli neri, folti e cresputi. Aveva l’aria assonnata, un’andatura greve, un fare quasi un po’ tonto, ma era solo un’apparenza, come sa bene chi lo ha letto e riletto alle prese con “quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, il capolavoro di Carlo Emilio Gadda.
Erano gli anni Venti e Ingravallo faceva parte dei pionieri nella polizia creata e rifondata attorno al 1919, anche per affrontare le turbolenze causate dai postumi della guerra mondiale sul territorio nazionale.
A tutti gli effetti, tale generazione fu la prima a cimentarsi secondo le norme e gli intenti del nuovo status, quello che poi lungo i decenni portò agli esiti attuali, per i quali (sempre parlando in senso letterario e cinematografico) l’esponente più conosciuto e amato è sicuramente il commissario Salvo Montalbano, l’eroe di Vigata.
Storia poco, anzi per niente nota quella che ha scandito le premesse della nostra polizia e lo sviluppo successivo, grazie alla continua trasformazione riguardante le conoscenze tecnico-professionali e la cultura investigativa sullo sfondo dei progressi scientifici avviati a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Se in Inghilterra furoreggiava la mitica Scotland Yard, in Italia, dopo l’unità nazionale composta tra 1860 e 1866, era proprio tutto da inventare e armonizzare anche per uscire da una tradizione negativa sia nelle modalità operative sia nella fiducia suscitata tra l’opinione pubblica su tali metodi. Bisognava scrollarsi di dosso l’imbarazzante e pesante fama legata a un nome, quello di sbirro, eredità del buio medioevo con etimologia della parola un po’controversa.
Per sapere tutto di questa vicenda, c’è un libro illuminante e sorprendente per quanto narra con minuziosa cura. Lo ha scritto Giulio Quintavalli, laurea in Storia e società a Roma, ispettore superiore sostituto commissario e da anni in servizio all’Ufficio storico della polizia di Stato, già autore di altre opere su tali temi.
Con l’editore Aviani&Aviani di Udine, ha pubblicato di recente questo “Da sbirro a investigatore. Polizia e investigazione dall’Italia liberale alla Grande Guerra” (280 pagine, con ampio corredo di documenti originali e fotografie) nel quale non ha voluto considerare i nomi famosi o la letteratura più d’evasione (gialli, polizieschi, eccetera) dando invece la parola alle fonti di carattere interno o vicine alla polizia e alla memorialistica legata direttamente ai detectives.
L’attenzione si concentra così sull’inizio Novecento quando si fanno largo la scienza e le nuove pratiche di indagine scientifica razionalizzando quelle tradizionali, tra codificate (verbali, interrogatori, perquisizioni) e non (travestimenti, pedinamenti, appostamenti).
Il vento rinnovatore dilata gli orizzonti professionali, a partire dai servizi investigativi svolti già durante la guerra, per “salvaguardare le spalle all’esercito” come si diceva. Un severo test arrivò con le indagini effettuate su attentati, sabotaggi, spy stories (arrivando fino all’entourage di Papa Benedetto XV) e sul triangolo mafia-diserzione-abigeato, ennesima emergenza criminale nel Sud dove oltre mille tra poliziotti e carabinieri operarono in sinergia, con risultati notevoli, e fu in pratica una squadra Antimafia ante litteram.
L’ingegno italiano si affermò presto nella detection, come pure nella classificazione delle impronte digitali, coniata nel 1910 da Giovanni Gasti e usata fino agli anni’90, o nella trasmissione a distanza delle immagini (detta teleiconotipia o ellerogramma), straordinaria per l’epoca e dovuta alla geniale figura del friulano Umberto Ellero.
Va ricordato infine che la prima foto segnaletica italiana fu quella di Giuseppe Garibaldi diffusa il 3 maggio 1860 dalla polizia borbonica. Anche questo primato toccò al generale! –
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








