Ecco i “segreti” sotto largo San Giovanni

PORDENONE. Periodicamente riaffiora la querelle sui cedri che sono stati recentemente abbattuti in largo San Giovanni per problemi di sicurezza e sostituiti con due tulipiferi e un faggio.
Ciò che meraviglia è che a quanto ho scritto lo scorso aprile sul Messaggero Veneto – segnalai che in questo luogo dovrebbero essere sepolte le fondamenta della chiesa dedicata a San Giovanni Battista, che si dice esistesse già nel 1349, come si legge nel Memoriale di Odorico da Pordenone, restaurata nel 1675 e poi demolita tra novembre e dicembre 1925 – non c’è stato alcun pordenonese che abbia condiviso questa proposta ed abbia invitato l’attuale amministrazione comunale ad intervenire per far avviare dalla Sovrintendenza uno scavo archeologico, al fine di mettere in luce i resti di questo luogo di culto e ricercare eventuali altre tracce del nostro passato.
Pordenone ha un notevole vuoto storico, individuabile tra la fine della romanità e l’alto medioevo.
La romanità è stata testimoniata in molti luoghi attorno a Pordenone, dopo l’encomiabile ricerca e raccolta di reperti effettuata in tanti anni di attività dal conte Giuseppe di Ragogna (1902-1970); come noto, a Torre, nei pressi della parrocchiale, ci sono le fondamenta di una villa romana del periodo augusteo da lui scoperta negli gli anni Cinquanta.
Pochi pordenonesi però ricordano l’esistenza di una estesa necropoli romana distrutta tra il marzo e il maggio 1954 a sud di via Rive Fontane, nell’area detta la cava degli “arsus” (ossia dei cremati) molto vicina a dove oggi è posta la rotonda tra viale della Liberta e viale Venezia, i cui reperti furono raccolti dal conte in quell’anno, con molta difficoltà e incomprensioni da parte del Comune e oggi conservati nel Museo archeologico di Torre.
Un’altra necropoli con tombe a tumulo esisteva lungo la via Vallona, testimoniata dallo storico Valentino Tinti (1771-1849): «… nella spianata che fu eseguita nel 1686 dei monticelli alla Vallona, furono trovate ossa gigantesche, medaglie antichissime, dardi arrugginiti…».
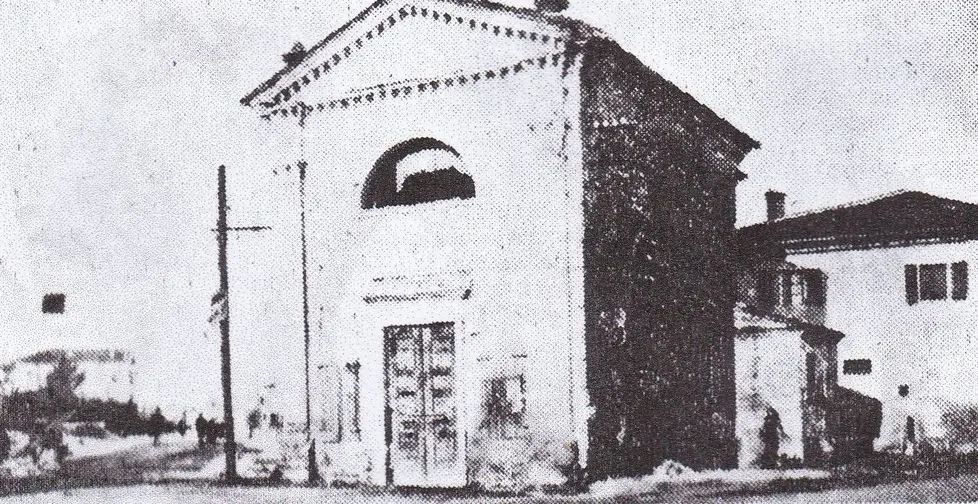
Due aree sepolcrali, quindi, poste ad est e ad ovest della vasta depressione che è ancora in parte visibile lungo viale della Libertà, che indirettamente segnalano un popolamento antico non solo verso Torre, ma anche verso i colli dove poi sorse Pordenone, che è indirettamente confermato dal Pomo (1709-1797) nella sua Cronaca, in cui ci ha segnalato che il 2 ottobre 1762 vennero ritrovati dei cimeli pagani nel sottosuolo del duomo di San Marco.
Nei secoli successivi alla romanità sino all’alto medioevo nulla si sa su Pordenone. Ad esempio l’erezione del castello al termine della piazza della Motta e quindi l’intera cinta muraria, Andrea Benedetti nel suo libro sulla storia di Pordenone, le ha fatte risalire dopo le invasioni ungariche, avvenute tra gli anni 899 e 942, quando il Friuli si popolò di castelli nei luoghi più strategici lungo la pedemontana e in pianura.
L’aver dedicato questa chiesa a San Giovanni Battista, che si dice però esistente prima del 1349, fu indubbiamente una scelta molto particolare, essendo posta al termine del più importante asse viario della città dove sono state erette la chiesa della Santissima Trinità, il duomo San Marco, le chiese del Cristo (Santa Maria degli Angeli) e di San Giorgio, per citare quelle oggi esistenti.

Non è noto a quale periodo risalga l’introduzione del culto di questo santo in Italia, se non supposizioni. La tradizione vuole che sia stato voluto da Teodolinda, moglie di Agilulfo, re longobardo nella metà del VII secolo. Altre versioni però ne posticipano la datazione al XI secolo, ma le prime vere testimonianze documentali risalgono solo alla fine del XIV secolo.
Per quale motivo questa chiesa è stata dedicata a questo santo a Pordenone? Si sappia che analoga dedicazione sembra fosse stata data anche alla chiesa posta all’interno del castello di Torre, messa in luce dal conte Giuseppe di Ragogna nel 1957.
Analoga dedicazione è stata data ad alcuni importanti luoghi di culto a Monza e a Firenze. A Monza fu eretta una chiesa, a lui dedicata, dai longobardi tra il VI-VII secolo poi ampliata tra il XIII e il XIV per l’erezione del duomo.
Analogamente a Firenze, il battistero fu edificato durante la dominazione longobarda tra il VI e VII secolo e questo santo è poi divenuto anche il suo patrono, che lo festeggia il 24 giugno.
San Giovanni Battista fu una figura ascetica, fu un santo anacoreta, venerato per il rigore e per l’austerità, modello di integrità morale che per primo fu voluto dai longobardi come protettore; ne parla anche Paolo Diacono nella sua Historia longobardorum.
Nulla si può ancora dire sull’antichità delle fondamenta della chiesa esistente in largo San Giovanni a Pordenone, oltre alle date segnalate.
C’è però da evidenziare che la presenza dei longobardi nel nostro territorio non era molto lontana dal luogo dove nei secoli successi sorse la città; un nucleo infatti era posto a Cordenons nella Cortina posta dove oggi c’è il cimitero (Naone corte regia, dove venne scritto il diploma di Berengario I del 5 maggio 897), un altro a San Foca (Curtis sancto Focate, citata nella Carta donazioni di Nonantola del 3 maggio 762) e un altro doveva essere posto a Dardago (Durdago) dove nel 1990 scavando in un cortile lungo via San Tommaso vennero rinvenute sette tombe longobarde (parte di una necropoli che è ancora sepolta e che si estende anche nei terreni adiacenti alla chiesa di Santa Maria) i cui reperti, in parte, sono stati recuperati ed oggi conservati nel Museo archeologico di Torre.
Per quanto ricordato, sarebbe doveroso che l’amministrazione comunale – se ha intenzione di ricostruire il nobile interrompimento in piazza della Motta, recuperando le colonne originali conservate negli scantinati delle Gabelli – dovrebbe far mettere in luce anche le fondamenta di questa antica chiesa: attraverso una indagine archeologica della Sovrintendenza si potrebbe risalire alla vera data della sua costruzione.
Le fondamenta, se meritano, sarebbe poi opportuno coprirle, almeno in parte, con delle lastre di cristallo (per non arrecare danno alla viabilità in largo San Giovanni) e porre nelle vicinanze un pannello didattico che le documenti. Un intervento che nobiliterebbe questo luogo di Pordenone, piuttosto che lasciarle sepolte sotto le piste ciclabili.
Ha poco senso protrarre la polemica sui cedri: l’amministrazione comunale valuti questa proposta dando testimonianza di sensibilità nei confronti di un antico luogo di culto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








