Il dolore e l'esilio
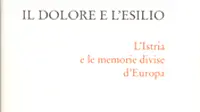
Donzelli editore
Saggine
Prima edizione 2005
120 pagine
11,90 euro
di Gianpaolo Carbonetto
E tutto questo con un metodo di indagine inconsueto e partendo da un punto di vista che in questo caso è praticamente inedito: quello dei letterati, degli intellettuali, degli uomini e delle donne che non rinunciano a ragionare e poi ad appuntare sulla carta ciò che vedono, sentono e provano; tutte persone che, viste a distanza di tempo, si rivelano essere stati quasi profeti inascoltati di quello che sarebbe accaduto, perché avevano saputo capire dal presente quello che sarebbe successo in futuro.
Quello di Crainz è una sorta di viaggio nel tempo attraverso mezzo secolo di storia di queste terre, che sono comunemente definite “estremo lembo orientale d’Italia” e che potrebbero essere definite – parafrasando Nievo – un “piccolo compendio dell’universo concentrazionario” e di quel secolo che alcuni hanno definito “breve”, altri “lungo”, ma che, in definitiva, può essere definito semplicemente “secolo crudele” in quanto il Novecento ha infierito sull’umanità con guerre e genocidi, ha visto nascere regimi totalitari che prima di estinguersi hanno causato lutti profondi ed estesissimi. Pensateci: in queste zone, a Trieste, nel 1945, nell’arco di pochi mesi i triestini hanno visto festeggiare in pompa magna il compleanno di Hitler, quello di Tito e quello di Giorgio VI d’Inghilterra. Una zona un po’ più vasta della nostra regione e dell’Istria ha visto alternarsi in meno di quarant’anni i governi, più o meno dispotici, degli Asburgo, dei Savoia, dei fascisti, dei nazisti, dei titini, degli alleati e della repubblica italiana. Già queste considerazioni potrebbero essere sufficienti per cominciare a spiegare le tensioni che hanno attraversato queste terre e che oggi, a distanza di sessant’anni, sembrano non essersi ancora del tutto sopite, anche perché cinicamente attizzate da personaggi che le usano puntando a ottenere vantaggi politici.
A conferma che la storia non è comprensibile se parcellizzata in brevi periodi avulsi dal resto del contesto contemporaneo, ma anche da quelli che li hanno preceduti, l’ambito di tempo preso in esame da Crainz allarga i suoi confini anche a qualche anno prima e a un bel po’ di anni dopo questo complicatissimo spazio temporale e lo esplora non riferendosi soltanto ai fatti accaduti, ma anche e soprattutto ai racconti che di questi fatti sono stati scritti e lasciati in eredità da persone che si trovavano di fronte ad avvenimenti drammatici e che, con grande coraggio, si rifiutavano di lasciar passare tranquillamente. Che non accettavano di farli scorrere sulla propria pelle senza cercare di interpretarli; ma, anzi, avvertendo sempre l’intima necessità di decidere da che parte stare e di tentare di comprendere dove questi avvenimenti avrebbero finito per portare. E poi, momento di altissima umanità, rifiutandosi di partecipare, sia pure con acquiescente omissione, a un divenire del mondo che ai più appariva inevitabile.
A un certo punto, in una lettura un po’ superficiale, potrebbe quasi sembrare che Crainz si riferisca a un mondo strettamente legato da un ferreo determinismo storico. Dalle violenze fasciste contro le minoranze slovene che non avrebbero dovuto più «parlare e nemmeno pensare nella loro lingua», alle feroci persecuzioni del generale Robotti che si lamentava che le truppe italiane ammazzassero troppo pochi abitanti dei villaggi sloveni, alle altrettanto feroci e indiscriminate vendette dei titini, alla tragedia dell’esodo di chi fu costretto a lasciare le proprie case, le proprie terre, parte dei propri cari per cercare asilo in una terra che loro volevano chiamare patria, ma che di loro avrebbe fatto volentieri a meno. Una spirale di violenza e di dolori che ha attanagliato per decenni queste terre, dando vita quasi a una faida tra nazioni e tra culture invece che tra famiglie.
Sembra di assistere a una serie di azioni e reazioni quasi obbligate che non possono non richiamare alla memoria la teoria fisico-matematica di Pierre Simon de Laplace che sosteneva che un matematico infinitamente bravo, conoscendo le condizioni iniziali dell’universo, avrebbe potuto scrivere in anticipo l’intero futuro di tutto il creato, anche se la parola creato, in questo caso, perderebbe ogni suo significato etimologico.
Però Crainz, in realtà, sostiene esattamente il contrario: in maniera quasi implicita, ma con l’esplicita ricchezza di citazioni scelte con grande cura e attenta ricerca, fa capire che bloccare l’andazzo è paradossalmente semplice e complicato assieme; comunque possibile. L’importante è saper dire di no. O, se non si ha la forza di dire di no, almeno saper ascoltare chi dice di no. Tutto questo può cambiare il corso della storia, può bloccare certe spinte, può impedire enormi disastri.
Molto importante è stata anche la scelta dei testi da utilizzare per comprendere meglio la storia: da Biagio Marin a Miroslav Krleza, da Ernesto Sestan a Enzo Bettiza, da Pier Antonio Quarantotti Gambini a Fulvio Tomizza, da Pier Paolo Pasolini a Giani Stuparich, e così via in una coloratissima antologia di citazioni che non può non far venir voglia di approfondire successivamente l’argomento. E infatti dichiaratamente Guido Crainz sostiene, nella sua introduzione, che «questo non è un libro di storia. È un piccolo quaderno di suggerimenti, di consigli di lettura: rimanda ad altre narrazioni e ad altre ricostruzioni storiografiche».
E continua: «Mescola realtà e immaginari, nella convinzione che la traccia di un sogno, o di un incubo, non sia «meno reale di quella di un passo, o del solco di un aratro sulla terra». Suggerisce un percorso, uno dei tanti possibili, per affrontare un nodo più generale. Cerca di comporre un’antologia di sguardi, di far dialogare parzialità differenti. Prende spunto e occasione dal dramma di un’area specifica e pone domande sul “dolore degli altri”, per riprendere le riflessioni di Susan Sontag . “Altre”, infatti, distanti da noi, sono apparse spesso alla sensibilità – o all’insensibilità – nazionale le diverse vittime che hanno vissuto in quell’intricato crocevia: italiane, slovene, croate.
Questi consigli di lettura si propongono solo di indicare un percorso che ce le faccia sentire meno “altre”: un percorso che ci aiuti, anche, a collocarle nel più ampio e tragico scenario di cui fanno parte. Questa storia lacerata rimanda infatti a una più grande rimozione. Ci fa capire anch’essa l’esigenza e l’urgenza di un confronto reale fra le differenti memorie di un’Europa che nel Novecento ha vissuto in modo diverso due guerre e due dopoguerra, e ha conosciuto opposti totalitarismi. Un confronto fra memorie individuali e collettive, passioni e ragioni, studi ed emozioni. Un orizzonte che dia dignità e “diritto di cittadinanza” ai differenti vissuti, chiedendo a essi unicamente il rispetto dell’“altro”».
È una parte di introduzione che già da sola potrebbe fungere da base di analisi e ragionamenti su quanto abbiamo fatto e quanto abbiamo sbagliato finora, che pone punti fermi importanti dai quali si è obbligati a partire: la pluralità delle fonti, il riconoscimento della dignità degli altri, la necessità di sforzarsi di conoscere tutti, l’obbligo di non limitarsi a definire “razzisti” i razzisti e “assassini” gli assassini, perché effettuando generalizzazioni indiscriminate e di comodo rischiamo di diventare razzisti e assassini pure noi. Perché c’è sempre la tentazione di indulgere a quella voglia di generalizzazione che è estremamente comoda, che evita di fare la fatica di dover conoscere, di pensare, di ragionare e di scegliere, ma che è anche l’anticamera del razzismo perché finisce per togliere agli “altri” la vita reale, riducendoli ad astrazioni, e finendo per ammassare tutti in grandi, ipotetiche e improbabili, categorie di popoli, di etnie, di religioni, di gruppi linguistici, dimenticando, o facendo finta di non sapere, che anche la categoria in cui ci si vede incasellati è sicuramente vista con disprezzo da qualcun altro e che l’unica specie a cui si deve fare riferimento è sempre soltanto quella umana. È la cultura, insomma, che deve sforzarsi a tenere gli “altri” vivi e a ricordare che l’umanità è così preziosa proprio perché è una sommatoria di individualità. È la cultura che deve ricordare a tutti che la parola “xenofobia” non è meno grave di “razzismo”: ne è soltanto l’orrenda anticamera.
Tutto questo, con il suo carico di difficoltà e fatiche, ovviamente, se vogliamo pensare al futuro, se puntiamo a lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato, se – in poche parole – vogliamo fare politica nel senso più nobile del termine.
E accanto alla cultura deve esserci la memoria. Scusatemi se non faccio distinzioni tra memoria e ricordo, due sinonimi usati non per far notare affinità, ma per rimarcare la differenza tra le cose che non si vogliono dimenticare. Per il momento abbiamo il “Giorno della Memoria” e la “Giornata del Ricordo” che finiscono per svilire un po’ il significato di una parola che invece è portante per qualsiasi civiltà. Come portante è in tutta l’opera di Crainz, perché ricordare è fondamentale per evitare il ripetersi di certi errori.
La contrapposizione di due sinonimi è la prova più appariscente del folle tentativo di oscurare una tragedia con un altra, contrapponendo due momenti dei quali il secondo sembra nato quasi per sminuire il significato del primo più che per evocare un’altro dramma umano e sociale. Perché quando il silenzio e il negazionismo non possono più razionalmente sussistere, la tattica cambia e si cerca di far sparire le realtà scomode non più tacendo, ma strillando nel tentativo di sopraffare le voci degli altri. Fa accapponare la pelle assistere ai tentativi di sminuire l’orrore della Risiera contrapponendogli la tragedia delle foibe. Ma purtroppo c’è chi lo fa in uno squallido gioco in cui quasi si teorizza che le vittime delle parti diverse finiscano per elidersi a vicenda cancellando le rispettive colpe in una specie di squallida e disumana partita doppia delle stragi. Ma le vittime dei massacri opposti non possono essere sottratte in questa folle contabilità. Invece finiscono per sommarsi proprio come in matematica, dove la somma di due numeri negativi dà un risultato che è, ovviamente, ancora più negativo dei due addendi separati. Anzi, addirittura si moltiplicano, dando la misura della mai sopita bestialità dell’uomo. Due ingiustizie non si elideranno mai a vicenda.
Parafrasando la frase scritta da Bertold Brecht nella Vita di Galileo, «Sventurata la terra che ha bisogno di eroi», si potrebbe dire «Felice quel popolo che non ha bisogno di Giornate della Memoria, o di Giorni dei Ricordo». È triste dirlo, ma il nostro certamente non è un popolo felice e ha ancora un disperato bisogno di ricordare per non ripetere gli errori – e soprattutto gli orrori – del passato. Ed è quasi avvilente rendersi conto del fatto che il ricordo diventa fondamentale in un periodo storico in cui la memoria non appare più come una virtù, ma addirittura come un fastidioso impedimento nella manipolazione di una realtà che diventa sempre più virtuale, che permette di mescolare resistenza, fascismo e nazismo ricordando a piena voce – e giustamente – che tutti i morti meritano identica pena, ma dimenticando ingiustificabilmente di dire che gli ideali per i quali hanno dato la vita sono diversi e hanno ben diversa motivazione e dignità.
Perché la necessità non è quella di mescolare ulteriormente le carte, ma anzi, al contrario, di riuscire a fare chiarezza perché la nostra repubblica è nata sui valori della resistenza e dell’antifascismo e fin quando questa Costituzione continuerà a esistere – e spero che questo avvenga ancora per moltissimi anni – e a basarsi su questi valori, non è ammissibile che siano messi sullo stesso piano coloro che al fascismo si sono opposti e coloro che il fascismo hanno sostenuto. E non perché i primi abbiano vinto la guerra e i secondi l’abbiano perduta, ma perché il fascismo è stato la firma delle leggi razziali, le guerre di aggressione coloniale, l’ingresso in guerra a fianco dell’orrore nazista, l’uccisione di Matteotti, dei fratelli Rosselli, di Amendola e di tanti dissidenti, l’invio al confino – e non in vacanza – di molti altri che si opponevano perché si rifiutavano di smettere di pensare; è stato la soppressione della libertà di stampa, l’eliminazione della maggior parte dei diritti civili, la dissuasione violenta nei confronti del libero pensiero.
Fame, terrore e morte sono la falsariga lungo la quale si snoda il percorso tracciato da Crainz seminando citazioni che non possono non far pensare, che riescono a far indignare e commuovere, avvampare di rabbia e sentirsi attanagliare dallo sconforto. «I versi delle elegie istriane del poeta gradese Biagio Marin – scrive Crainz – ci riconsegnano il dolore dell’esodo del secondo dopoguerra, che l’Italia ha ignorato a lungo. L’Italia, cioè ciascuno di noi. Difficile negare che abbiamo chiuso gli occhi per decenni o usato lenti deformanti. Perché? È molto difficile rispondere, anche perché non erano mancate voci di straordinaria sensibilità, capaci di farci comprendere le radici e i contorni di un dramma».
È forse questo l’aspetto più affascinante e terribile insieme de Il dolore e l’esilio. Il fatto è che l’umanità soltanto raramente è stata capace di riconoscere i profeti – e bene è andata quando non li hanno ammazzati – soprattutto quando si ergono a coscienza critica del potere. Forse anche perché spesso questi profeti indossano i panni dimessi degli scrittori, dei poeti, dei filosofi, di coloro che amano passare il loro tempo a leggere, parlare, ascoltare, discutere.Forse gli uomini non si rendono conto che facendo così hanno reso possibili i fili spinati, i vagoni piombati, le pulizie etniche, le esecuzioni di massa che non hanno colore, ma soltanto identica disumanità. E che – come abbiamo visto sul finire del secolo scorso, non sono affatto fantasmi del passato, ma incubi del presente.
E questi incubi sembrano ancora lontani dallo scomparire, sia a causa del dolore, sia a causa dell’odio che hanno provocato. Lord Byron in Marin Faliero, doge di Venezia, ha scritto: «Il ricordo della felicità non è più felicità; il ricordo del dolore è ancora dolore». Verissimo. Ma se nella realtà il dolore resta acuto, inevitabilmente l’odio finisce per stemperarsi con il passare degli anni. Chi – tanto per fare un esempio – oggi associa automaticamente il concetto di tedesco con quello di nazista? Ma questo accade, ovviamente, se nessuno si dedica con cura quasi maniacale a tenerne vivo il fuoco.
Guido Crainz nel suo libro affronta con decisione anche questo problema che è il più grave perché legato a fatti di sangue, il più abominevole perché fondato nel razzismo, o almeno nella xenofobia, il più radicato nell’anima e nell’immaginario collettivo. Ma Crainz annota anche con chiarezza che sarebbe sbagliato sottovalutare – non tanto nella valutazione dei fatti, ma delle loro conseguenze – l’effetto indotto dall’esilio forzato di migliaia di persone dalle loro terre. Perché l’esilio ha innegabilmente esasperato gli animi, sia per la violenza – non soltanto fisica, ma anche psicologica – esercitata da coloro che hanno deciso la cacciata, sia perché in Italia c’è stata una tangibile difficoltà di accoglienza da parte di coloro che non vedevano arrivare fratelli più sfortunati, ma estranei che casualmente parlavano la stessa lingua, ma in realtà invadevano una terra che non era loro e che, soprattutto, andavano ad affollare i precari spazi lavorativi in un periodo in cui la ricchezza era scarsa, mentre la fame era ancora molta.
Nulla di nuovo sotto il sole, intendiamoci. Lo vediamo succedere oggi con la guerra tra poveri che contro gli immigrati extracomunitari combattono alcuni strati maggiormente disagiati della popolazione. E succedeva anche una volta come magnificamente nel canto XVII della Divina Commedia, Dante fa dire a Cacciaguida: «Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco de lo essilio pria saetta. / Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Una splendida descrizione della lacerazione dell’addio e dell’amara considerazione che l’accoglienza fraterna spesso è un sogno e raramente una realtà.
Credo che accanto alla pietas per le vittime, sarebbe molto utile ricordare i carnefici e l’ideologia che li spinse perché soltanto così si può capire come nasca un abominio e come si può evitare che ritorni. E così nella Giornata del Ricordo sarebbe sbagliato ricordare soltanto il dramma delle foibe, in quanto si finirebbe per limitare la nostra attenzione ai cattivi propriamente detti, a quelli che spiccano per malvagità: aguzzini e assassini fascisti, nazisti, comunisti titini e, da tutte le parti, delinquenti comuni che hanno approfittato della situazione. Sarebbe comodo, ma non è giusto perché una giornata del genere deve far tornare a galla anche le mezze tinte, i chiaroscuri delle nostre coscienze, la consapevolezza che anche noi non ci siamo comportati particolarmente bene quando abbiamo anteposto il benessere personale alle disgrazie altrui, quando usavamo la deprecazione degli altri per nascondere le nostre crudeltà, meno sanguinarie, ma non per questo meno dolorose. E in questo richiamarci alle nostre responsabilità Crainz è stato implacabile, utilizzando parole sue e di altri.
Perché la storia non è affatto finita, come ha sostenuto assurdamente lo statunitense Francis Fukuyama alla caduta del muro. Anzi. Come è assurdo il concetto di “storia condivisa”. Assurdo oltre che sbagliato. Assurdo perché non vedo proprio cosa potrei condividere nei giudizi storici di fascisti o ex fascisti, perché non vedo come potrei mettere sullo stesso piano i partigiani e i soldati della Repubblica sociale italiana. A meno di non prefigurare, in un prossimo futuro di piangere le stesse lacrime per ebrei, rom, omosessuali, handicappati, asociali e oppositori politici passati per un camino di Auschwitz e per gente come Eichman che in comune con i primi ha soltanto il destino del suo corpo dopo la morte: essere diventato cenere.
Sbagliato perché come non dovremmo coprire la nostra coscienza collettiva con spesse mani di vernice che ha il colore delle cattiverie altrui e che nasconde quello delle nostre, così non dovremmo permettere che neppure gli altri lo facciano. Ma se qualcosa potesse cambiare, comunque non parlerei di una storia condivisa, ma, eventualmente, di un futuro condivisibile senza mai rinnegare le proprie radici, per convinzione e dignità propria e per credibilità nei confronti degli altri.
La strada da seguire potrebbe essere proprio quella utilizzata da Guido Crainz per realizzare questo libro e sollecitare la nostra coscienza: andare ad ascoltare le vittime di qualunque parte siano; verificare le loro storie; custodire le loro memorie, condannare il silenzio, perché non è tacendo che si possono far passi in avanti in quanto il silenzio, impedendo di conoscere – e quindi di avere gli strumenti per giudicare – è il più grande nemico della democrazia.
Una cosa irreale? Può anche essere, ma non è un problema se c’è in giro gente come Crainz che è un irragionevole di prima forza: in un paese che vive di televisione, lui pensa a scrivere un libro. E lo scrive aiutandosi con cose già scritte: il colmo dello sberleffo per quelli dell’area De Filippi. E vende. E fa discutere. Altro che cercare di andare in contro a chi non legge. Altro che mediare fino alla disperazione. Torniamo a dire quello che realmente pensiamo. Forse troveremo qualcuno di più che ci crede sinceri.
Irragionevole anche questo? Forse. Ma ricordate che l’uomo ragionevole si adatta al mondo, mentre l’irragionevole insiste nel tentare di adattare il mondo a sé. Quindi, ogni progresso dipende solo dall’uomo irragionevole. L’ha detto George Bernard Show e gente come Crainz lo mette quotidianamente in pratica.
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








