Ottant’anni fa l’addio al genio pordenonese che illuminò Venezia
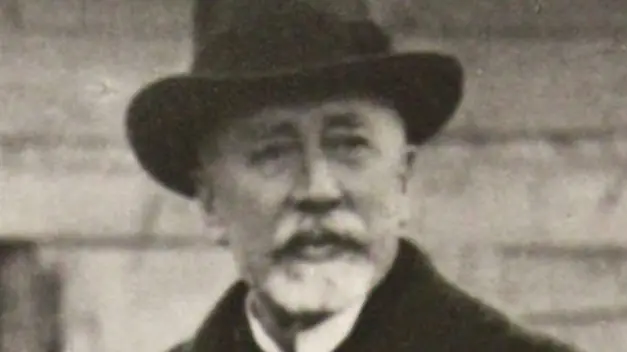
Se Udine si illuminò d'immenso durante l'Ottocento, Pordenone non fu da meno. La luce arrivò in entrambe le città nello stesso anno e grazie a due straordinari personaggi, di cui molto si sa, ma che probabilmente non sono stati mai raccontati in una narrazione parallela. L'udinese in questione era Arturo Malignani, di cui nel 2015 ricorrevano i 150 anni dalla nascita. La sua vicenda è stata proposta in una bella mostra a cura di Elena Commessatti e del pronipote Federico. L'episodio centrale fu il viaggio compiuto nel 1896 quando Arturo da solo si imbarcò su una nave e raggiunse gli Stati Uniti per illustrare la sua idea, subito acquistata e brevettata da Edison, idea che ebbe un'importanza rivoluzionaria permettendo l'uso prolungato e sicuro della lampadina. E fu Arturo, nel 1888, con l'appoggio di un imprenditore spilimberghese, Marco Volpe, a realizzare a Udine il primo impianto di illuminazione elettrica pubblica. Nello stesso anno anche Pordenone ebbe tale regalo, potendo condividere un primato perché poneva le nostre piccole città al livello di Londra o Milano.
Ragazzo d’ingegno. Pure nel caso pordenonese tra i protagonisti c'era un ragazzo di ingegno, ancora universitario, che conobbe benissimo Malignani perché le loro vite percorrevano sentieri analoghi, fatti di orgoglio, sacrificio e situazioni comunque favorevoli a giovani promettenti. Questa è la storia di Antonio Pitter, pordenonese nato nella frazione di Rorai Grande il 14 aprile 1867. E' significativo ricordarlo in questi giorni perché lunedì 29 febbraio ricorreranno gli 80 anni dalla morte, avvenuta a Venezia nel 1936. Rileggendo i momenti salienti della sua esistenza (attraverso i saggi e i numerosi articoli scritti dal nipote, avvocato Pompeo Pitter) è possibile tracciare una lettura simile a quella dedicata ad Arturo Malignani. E da tali analogie potrebbe spuntare l'idea di un'iniziativa comune incentrata su figure eccezionali e ricche di insegnamenti per i tempi attuali.
Storie parallele. L'inventore udinese era nato nel marzo del 1865, il pordenonese un paio di anni dopo. Arturo era figlio di Giuseppe Malignani, pittore, ritrattista e fotografo, artistoide un po' irregolare. Il papà di Antonio era direttore tecnico della tessitura di Rorai e architetto: firmò come opera principale il progetto per la chiesa di Porcia e presentò quello per la facciata del duomo San Marco di Pordenone, che non venne realizzata per motivi economici. La mamma, Maria Salice, era cugina dell'abate Giovanni Toffoli, buon pittore e ritrattista (ed ecco una somiglianza con la storia di Arturo). Entrambi restarono orfani presto: la mamma di Arturo morì per complicazioni del parto e il padre alcuni anni dopo. Analoga sorte per Antonio perché papà Silvio venne a mancare nel 1875 lasciando la famiglia, mamma e quattro figli, in gravi ristrettezze. Non sono dati irrilevanti in quanto le vicende dei due ragazzi cominciano proprio da lì, cioè da zero.
L’industria elettrica. Il pordenonese, grazie alle borse di studio, frequenta a Venezia l'Istituto tecnico e poi a Milano il Politecnico, laureandosi nel 1889 con il titolo di ingegnere elettrotecnico, che nell'Italia e nell'Europa di allora rappresentava quanto di più nuovo, avanzato, moderno potesse esserci. Proprio nel decennio in cui Pitter compì gli studi nasceva a Milano l'industria elettrica italiana con la famosa centrale di via Santa Renegonda. Antonio era studente quando nella sua Pordenone, nel 1888, fu inaugurato l'impianto di illuminazione pubblica. E il giovane d'ingegno, che collaborò all'iniziativa, scrisse in un articolo: “Pordenone ha compiuto un nuovo e importantissimo passo sulla via del progresso e noi tutti salutiamo con entusiasmo questo giorno che resterà memorabile nella storia della città...”. Nell'occasione venne edita una pubblicazione celebrativa nella quale Antonio, sotto il titolo “Fili e lampade”, fingendo di rivolgersi a una immaginaria “lettrice gentile”, spiegava in tono discorsivo segreti e principi dell'elettrologia. Analoga la storia di Malignani, ma con differenze negli esiti finali essendo uno studente incostante. Dopo il diploma all'Istituto tecnico di Udine, si iscrisse al Politecnico (più o meno nello stesso periodo di Pitter), ma mollò dopo alcuni mesi. Nel suo caso, decisivo fu l'incontro con l'ingegner Giuseppe Colombo, il progettista della centrale di via Santa Renegonda. Arturo preferì tornare a casa (e a Udine rimase tutta la vita, fino alla scomparsa nel 1939) avviando un'attività imprenditoriale multiforme con il sostegno della sorella Adele.
Nume protettore. Anche nel caso di Antonio Pitter ci fu un nume protettore importante, il conte Nicolò Papadopoli Aldobrandini, veneziano di origine cretese, sbarcato a Pordenone per attività di natura economica e politica (fu eletto deputato per un paio di legislature). Il facoltoso finanziere capì che Pitter era un ragazzo dotato di volontà e viva intelligenza e lo aiutò. Conseguita la laurea, cominciò la carriera di Antonio in una continua ascesa. Prima ad Ancona e Barletta con la Società strade ferrate meridionali, ma tutto cambiò quando nel 1900 venne assunto dalla Società Cellina come direttore per la parte elettrotecnica del gigantesco impianto idroelettrico realizzato in appena cinque anni. Quello stupefacente insieme di opere che ha il suo simbolo nella centrale di Malnisio rappresenta uno dei principali monumenti in regione allo spirito di iniziativa e all'ingegnosità umana. Il ricordo della grande impresa industriale, che aprì il Novecento nel segno della speranza, è stato oggetto di studi e rievocazioni non prive certo di nostalgica ammirazione per un dinamismo e un'audacia vissuti come sfida coraggiosa a favore del progresso.
Energia per Venezia. Entrata in funzione, la centrale produceva energia che serviva a illuminare anche piazza San Marco a Venezia, la città dove l'ingegner Pitter andò a vivere assieme alla mamma e alla sorella Matilde, prendendo in affitto una casa in campo Sant'Angelo e poi acquistandone una sul Canal Grande. Anche la Società Cellina, di cui divenne direttore generale, aveva sede in calle Goldoni. Divenne così tra i protagonisti del risveglio veneziano dopo il torpore dell'Ottocento, al fianco di Giuseppe Volpi. Furono tanti i progetti e le imprese affrontate, prima fra tutti l'impianto Piave-Santa Croce. Pitter si spense nel 1936, benvoluto e stimato, e dopo i funerali a San Marcuola fu sepolto nella tomba di famiglia a Rorai Grande. La Sade gli dedicò la centrale di Malnisio e il Comune di Pordenone una strada. Creò tante cose, qualche sogno restò irrealizzato, come la sistemazione del Tagliamento. Un autentico pioniere e per ricordarlo si deve tornare sul Cellina, tra i suoi paesaggi, i paesaggi dell'energia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto








